Il “caso gesuiti”. Giovanni Paolo II convoca una riunione segreta in Vaticano
Giovanni Paolo II si rese conto fin dai primi anni del suo pontificato della deriva catto-comunista della Compagna di Gesù guidata dal basco Pedro Arrupe. Nel 1981 convocò una riunione segreta in Vaticano con i cardinali più importanti della Curia. All’ordine del giorno vi era una non remota ipotesi: sopprimere ancora una volta la Compagnia come fece Clemente XIV. Perché ciò non avvenne? Leggete queste pagine e lo scoprirete.
Estratto del libro “I gesuiti e il tradimento della Chiesa di Roma” di padre Malachi Martin (Sugardo Edizioni, 1988)
Nonostante la forza della sua volontà, Giovanni Paolo II non è arrivato al soglio pontificio già dotato di romanità. La situazione in Polonia e in Nicaragua non gli metteva certo a disposizione del tempo. Seduto a capotavola, nelle sue vesti bianche, quel giorno Sua Santità sembrava contenere a stento la sua forza prorompente.
Primo papa polacco, a sessantun anni era una personalità in ascesa, piena d’iniziativa, circonfusa di carisma personale, una figura di primo piano nei media internazionali. Con tutto il potere del papato dalla sua parte, quale prelato avrebbe potuto resistergli?
Romanità o no, Karol Wojtyla è un uomo avveduto. Sicuramente, gli bastò guardare i sei uomini riccamente vestiti di rosso per capire quale fosse la posizione di ognuno non solo a proposito della Compagnia di Gesù, ma della strategia papale nel suo complesso.
Sulla poltrona immediatamente alla destra del papa sedeva Dottrina — il cardinale incaricato di controllare la purezza della dottrina cattolica nel vasto e variegato mondo della Chiesa. Bavarese dal viso mellifluo, saggio e per niente semplice, «Dottrina» era un teologo professionista con la tipica sicurezza dell’ecclesiastico intellettuale. A 55 anni, con tutti i capelli bianchi, era il più giovane dei presenti. Giovanni Paolo II sapeva che «Dottrina» avrebbe dato tutto il suo appoggio alla volontà del papa.
Come avrebbe fatto Propaganda, il cardinale responsabile della diffusione del cattolicesimo fra i popoli non cristiani dell’Africa e dell’Asia. «Propaganda» era un brasiliano di origine italiana, con un aspetto più venerando e più santo dei suoi colleghi. Di lui si diceva che era semplice come una colomba e non astuto come un serpente. Ma probabilmente era perché i suoi colleghi cardinali non sapevano mai che cosa aspettarsi da lui. Era noto che, nonostante la semplicità e la franchezza del suo stile, «Propaganda» sapeva far esplodere con grande precisione una bomba nel corso di una discussione.
L’ultimo alleato di Giovanni Paolo II alla riunione di quel giorno era Clero, il cardinale a capo della congregazione del Santo Uffizio, da cui dipendevano tutti gli ecclesiastici diocesani cattolici.
Degli altri tre cardinali presenti di uno non era detto che si mettesse contro il papa, ma non era neppure detto che si mettesse dalla sua parte. Vescovi, il cardinale che soprintende tutti i vescovi cattolici, era un maestro di romanità. Intelligente, giovane per i suoi 68 anni, una volta era arrivato vicino a essere eletto papa. Sapeva come ricavare un utile dal suo appoggio. Poteva mettere il suo peso dalla parte del papa, in cambio di un appoggio in altre questioni.
Religiosi, supervisore vaticano di tutti gli ordini religiosi maschili e femminili, era un argentino di sangue italiano che sicuramente si sarebbe opposto a Giovanni Paolo II. Era amico intimo di uomini in posizione elevata cui non piacevano i papi che davano scossoni alla barca, e di uomini in posizioni segrete che non desideravano il trionfo del papato in generale e aborrivano questo papa in particolare. Dalla testa curata agli immacolati polsini allacciati con preziosi gemelli d’oro, «Religiosi» dava l’idea di un uomo dall’eleganza asettica.
Al tavolo l’uomo più importante dopo il pontefice era Stato, il cardinale segretario di Stato del Vaticano. «Stato» era in tutto e per tutto l’opposto del papa. Quanto Giovanni Paolo II era robusto ed atletico, tanto «Stato» era minuto, con le guance così infossate da guadagnarsi il soprannome di «teschio». Il contrasto fra il colorito esangue della pelle e il rosso delle labbra e delle orecchie dava l’impressione che si fosse esposto a un vento polare.
Dei prelati della sua generazione, «Stato» era l’unico ad essersi conquistato una certa libertà d’accesso in URSS e nei paesi satelliti. Ma anche questi rapporti erano esangui come il suo colorito: il papa slavo era già riuscito a trovare ben altri contatti oltre cortina. Ma l’uso avveduto della romanità sa trasformare tenui entrature in grandi vantaggi. In ogni caso, dal punto di vista di «Stato», era probabilmente troppo poco il tempo che questo nuovo papa era al potere. Cunctando regitur mundus.
È interessante sapere che la riunione non era stata richiesta dal papa, ma da uno o da due dei cardinali presenti, per avere «chiarificazioni» dei piani del pontefice a proposito dei gesuiti.
Fu così che quando il papa bianco aprì la riunione con un discorso di «chiarificazione» di dieci minuti, sembrò che Pedro Arrupe, il papa nero, fosse l’ottavo invisibile invitato. Tutti e sette i presenti conoscevano il settantatreenne basco dal naso aquilino. E nessuno lo amava. Al massimo qualcuno lo considerava un alleato utile, mentre per gli altri non era che un pericolosissimo nemico. Sua Santità aveva imparato a temerlo.
Spiegando il suo punto di vista sulla Compagnia di Gesù, Giovanni Paolo II centrò le sue affermazioni soprattutto a proposito della fedeltà al papato e alla diffusione dell’autentica dottrina cattolica.
Quando il papa ebbe finito, «Religiosi» dichiarò la sua opinione. Anche se formalmente ossequiente, questa non corrispondeva pienamente a quella del pontefice. Dopotutto, ciò che il Santo Padre imputava ai gesuiti, poteva benissimo essere imputato ad altri ordini religiosi — francescani, carmelitani, domenicani ecc. E con la stessa colpa si potevano trovare i vescovi in America Latina e in tutto il mondo.
Per illustrare questo secondo punto, «Religiosi» citò due esempi fra i più ovvi. L’ex vescovo di Cuernavaca, in Messico, Mendez Arceo, cominciava i suoi sermoni domenicali salutando a pugni chiusi e gridando: «Soy marxista!» (Sono marxista!). E il suo venerabile collega, Evaristo Arns di San Paolo in Brasile non perdeva occasione per attaccare il capitalismo e lodare l’idea di una distribuzione della ricchezza che mettesse fine alla povertà endemica. E cosa dire di quei vescovi francesi che insistevano per mettere la nascita di Karl Marx nel calendario liturgico ufficiale della Chiesa insieme con quella dei santi e dei martiri? O quei vescovi canadesi che parlando della questione sociale di Marx si riferivano all’idea di lotta di classe di Marx?
«Religiosi» era certo che il suo venerabile collega «Vescovi», che sedeva accanto a lui e che aveva la responsabilità di tutti i vescovi, poteva verificare ciò che stava dicendo.
Probabilmente «Religiosi» riteneva che «Vescovi» non aveva ancora deciso che posizione prendere, ma questa era una valutazione sbagliata.
«Vescovi» aveva delle ottime ragioni per non aiutare «Religiosi». Dopo «Stato», «Vescovi» era il cardinale più potente di tutta la curia. A capo della congregazione dei vescovi, poteva — se voleva — avere un peso decisivo nella nomina di tutti i vescovi, tranne in terra di missione, dove l’ultima parola spettava a «Propaganda». Ma «Vescovi» era anche presidente della commissione pontificia dell’America Latina, una posizione che gli procurava un’enorme influenza. Era noto che «Vescovi» condividesse con Giovanni Paolo II due idee: che l’America Latina doveva essere salvata dal marxismo, e che non c’era molta differenza tra i marxisti espliciti in America Latina e il grosso dei gesuiti, dei domenicani, dei francescani e dei padri di Maryknoll. «Ciò che succede in America Latina», aveva detto «Vescovi» due anni prima, «determinerà, umanamente parlando, le sorti della Chiesa per il prossimo secolo».
No, «Vescovi» non avrebbe accolto l’invito implicito di «Religiosi». Molti di quei vescovi di sinistra dell’America Latina erano stati nominati prima che «Vescovi» avesse il controllo sulle nomine. Fu così che «Vescovi» rimase in silenzio.
Non importava. «Religiosi» era pronto a difendere i gesuiti affermando che agivano in completa obbedienza dei vescovi della Chiesa, che erano, non c’era bisogno di ricordarlo ai presenti, i successori dei dodici apostoli. Il Concilio Vaticano II aveva sottolineato il ruolo del collegio dei vescovi nel governo della Chiesa e nella guida dei fedeli. Il vero problema, secondo «Religiosi», non erano i gesuiti. E neppure i vescovi, che nelle loro diocesi dovevano affrontare il problema in prima persona. Per «Religiosi», il vero problema era la frattura tra i 3.567 membri del collegio dei vescovi e la Santa Sede. «Religiosi» evitò ogni menzione diretta alla persona di Giovanni Paolo II. Ma sul significato delle sue parole non c’erano dubbi.
Secondo la sua analisi, concluse «Religiosi», sia il governo sia l’autorità d’insegnamento della Chiesa dovevano essere condivisi normalmente tra il pontefice e il collegio dei vescovi. Forse il Santo Padre avrebbe consentito che la riunione si dedicasse a questo vero problema: la mancanza di coesione — in realtà il dissenso e la disunione — che esisteva tra la Santa Sede e i vescovi. In ogni caso, i gesuiti non dovevano diventare i capri espiatori di chi aveva colpe ben più gravi — ben più gravi perché maggiore era la sua responsabilità nella Chiesa universale.
La posizione di «Religiosi», pur franca e profondamente antagonistica con quella del pontefice, fu espressa in termini accettabili di romanità. Nessun gesto. Nessun dito ammonitore. Mai un tono troppo alto di voce. Così fu per la reazione dei sei. Nessun movimento o gesto tradì l’emozione. Tutt’al più una rapida occhiata all’oratore, a un amico o a un alleato.
Non ci fu neppure una corsa per chi dovesse parlare per primo. In una riunione di quel tipo è la romanità a presiedere. E la romanità indicava inevitabilmente «Dottrina», il teologo professionista seduto alla destra del papa con il compito di controllare la purezza della dottrina cattolica.
«Dottrina» voleva ricordare ai venerabili colleghi le parole con cui il Concilio Vaticano II descriveva il collegio episcopale. Citò il documento in questione: il collegio episcopale doveva «sempre e necessariamente essere inteso col suo capo che, nel collegio, manteneva nella sua integrità l’ufficio di pastore supremo della Chiesa universale e di vicario di Cristo».
In altre parole, sottolineò «Dottrina», era falsa distinzione parlare, come aveva appena fatto il venerabile collega, del collegio episcopale in quanto distinto e separato dal pontefice romano. Invece, senza pontefice romano, non c’era collegio episcopale. Al contrario, l’unica vera distinzione che si poteva fare era tra il pontefice da solo e il collegio dei vescovi che necessariamente comprendeva il pontefice. Il pontefice poteva agire da solo. Il collegio non poteva agire senza il pontefice. Quindi, qualsiasi vescovo che fosse in disaccordo con il pontefice — e il venerabile collega aveva appena assicurato che ce n’erano molti — era in disaccordo con il collegio episcopale. «Dottrina» era sicuro che «Vescovi» si sarebbe preoccupato — dato che dopo tutto era suo dovere — di richiamarli all’ordine.
Un bel colpo di romanità, come non se ne vedevano da tempo. Ma nessuno ebbe un cenno di trionfo o di disappunto. In realtà «Dottrina» non aveva ancora finito.
In quanto ai gesuiti, continuò, il caso era diverso da quello dei vescovi. Il collegio dei vescovi era stato fondato da Dio. I gesuiti erano stati stabiliti dal pontefice. A questi dovevano la loro esistenza e la loro fedeltà. Sua Santità diceva che erano in rivolta. Come il papa li aveva creati, il papa poteva richiamarli o al limite sopprimerli. L’oggetto di quella riunione era appunto il richiamo all’ordine o la soppressione dei gesuiti.
Il tentativo di «Religiosi» di sviare il tema della riunione era stato amputato drasticamente.
Senza nessun iato della discussione, tuttavia, «Stato» si lanciò in una difesa. Il suo approccio fu molto più indiretto di quello di «Religiosi». «Stato» ricordò ai venerabili colleghi di aver avuto insieme all’attuale Santo Padre più di un incontro con il diplomatico sovietico Ànatoly Adamshin, l’ultimo dei quali nello stesso 1981. Sua Santità aveva garantito ai sovietici che da parte del Vaticano come da parte della gerarchia polacca e dei leader di Solidarnosc non sarebbe stato detto o fatto niente in violazione del patto fra Mosca e il Vaticano del 1962.
«Stato» non aveva bisogno di spiegare ai presenti che nella primavera del 1962 un certo cardinale Eugene Tisserant era stato mandato da Giovanni XXIII ad incontrare un prelato russo, un certo metropolita Nikodim, che rappresentava il polit-buro sovietico del premier Nikita Kruscev. Papa Giovanni desiderava ardentemente sapere se il governo sovietico avrebbe consentito a due membri della Chiesa ortodossa russa di assistere al Concilio Vaticano II che si sarebbe aperto nell’ottobre successivo. L’incontro tra Tisserant e Nikodim aveva avuto luogo nella residenza ufficiale di Paul Joseph Schmitt, allora vescovo di Metz, in Francia. Nikodim aveva portato la risposta dei sovietici. Il suo governo avrebbe acconsentito, purché il papa avesse garantito due cose: che il prossimo concilio non avrebbe emanato una condanna del comunismo sovietico o del marxismo e che la Santa Sede avrebbe accettato come regola futura di astenersi da simili condanne ufficiali. Nikodim ottenne ciò che chiedeva. Tutta la faccenda fu orchestrata per conto del papa dal cardinale gesuita Augustin Bea finché non si arrivò a un accordo conclusivo a Mosca i cui termini furono rispettati nel concilio e nei due successivi decenni di politica vaticana.
«Stato» disse che aveva solo due domande. Il Concilio Vaticano II e i due papi che erano successi a Giovanni XXIII avevano rispettato gli accordi. Li avrebbe rispettati anche Sua Santità? E cosa avrebbero fatto la gerarchia polacca e i leader di Solidarnosc?
La vera domanda di «Stato» era così chiara che non c’era bisogno di formularla: come poteva Giovanni Paolo II mettere sotto accusa i gesuiti per l’appoggio che davano ai pensatori marxisti e ai guerriglieri comunisti in America Latina senza condannare esplicitamente il marxismo sovietico e i suoi alleati comunisti? Senza, in altre parole, violare non solo il patto di Metz, ma l’assicurazione che lui stesso aveva dato ad Adamshin che «Metz», come generalmente ci si riferiva a quel trattato poco conosciuto, sarebbe stato rispettato nel corso del suo pontificato?
Il messaggio di «Stato» fu allora chiaro. Pur sapendo che le deviazioni dottrinali dei gesuiti potevano benissimo essere riprovate in termini che non avrebbero violato alcun patto o accordo, voleva proteggere la Compagnia. Che cosa avrebbe fatto Sua Santità? Si sarebbe battuto, o avrebbe accettato il compromesso?
Sperando probabilmente nella seconda alternativa, «Stato» continuò ricordando che il padre generale Arrupe aveva appena pubblicato un articolo che dimostrava che nessun cattolico, né tanto meno un gesuita, poteva fondarsi su un’analisi marxista della società e della storia per decidere da che parte stare nella «lotta fra le classi». Il cardinale segretario dimenticò di far notare che Arrupe aveva aspettato più di tre mesi, dal 30 dicembre 1980 al 4 aprile 1981, per pubblicare quell’articolo; o che le circostanze della pubblicazione sembravano indicare che il generale era stato messo sull’avviso degli argomenti di cui si sarebbe trattato in quella riunione ristretta.
«Stato» aveva concluso la sua difesa dei gesuiti; ora non gli restava che venire all’argomento della strategia papale. In pratica significava alzare il tiro.
«Stato» ricordò ai presenti che la sua posizione di segretario di Stato di Sua Santità gli imponeva di mantenere rapporti cordiali, anche se non ufficiali, coi governi dell’URSS e del blocco orientale. Era vero che nel migliore dei casi non erano che tenui relazioni, ma era molto meglio della posizione di molti altri governi nei confronti della comunità socialista. Per mantenere quei legami avrebbe dovuto prendere le distanze da ogni affermazione della Santa Sede che offendesse quella comunità. L’avvertimento di «Stato», e la sua minaccia di dimissione e di aperta opposizione era chiara; e gli altri sapevano che per ragioni sue Giovanni Paolo II non voleva privarsi della collaborazione di «Stato».
«Stato» assicurò Sua Santità e i venerabili fratelli che nessuno era essenziale nella vigna del Signore e che l’ultima decisione spettava a Sua Santità. Tuttavia, «Stato» e il suo ufficio erano stati singolarmente utili a Sua Santità nella gestione di Solidarnosc — per tutti gli aspetti, sia politici sia materiali, di quel difficile affare.

Paul Marcinkus, presidente dello IOR dal 1971 al 1989. Rimase invischiato nel crack Banco Ambrosiano. Si “salvò” grazie al passaporto diplomatico della S. Sede.
I presenti conoscevano il ruolo che aveva avuto «Stato» nel trasmettere fondi della Banca Vaticana attraverso canali neutrali — società a proprietà vaticana o straniera, per esempio, società finanziarie estere di cui il Vaticano aveva il controllo — nei forzieri sempre vuoti di Solidarnosc. La posizione di «Stato» lo rendeva membro di diritto del Peca, la prefettura vaticana per gli affari economici. Il Peca prende tutte le decisioni importanti riguardo i movimenti dei capitali del Valicano. Giovanni Paolo li, tuttavia, come molti papi, ha familiarità con l’intricata rete di società finanziarie e di compagnie all’interno della ramificazione della Banca Vaticana. Strettamente parlando, «Stato» avrebbe potuto vietare ogni trasferimento di fondi, mentre, se i piani del pontefice si fossero realizzati, Solidarnosc avrebbe avuto bisogno di una quantità ancora più grande di denaro.
«Stato» non aveva che un commento da fare. L’anno prima la cooperazione con Sua Santità in materia di fondi aveva acquistato un elemento di pericolo. Il governo italiano continuava la sua inchiesta sullo scandalo che era scoppiato nel Banco Ambrosiano di Milano e che aveva investito con la sua onda il mondo della finanza internazionale. A torto o ragione, il Banco Ambrosiano e il suo direttore, Roberto Calvi, indicato come il responsabile dello scandalo della banca, erano stati associati con importantissimi e clandestini finanziamenti a Solidarnosc.
Naturalmente il segretario era fiducioso che la reputazione della Santa Sede e il lavoro del Santo Padre per la sua amata Polonia non avrebbero avuto a soffrirne. Nessuno poteva mettere in dubbio la sua devozione agli interessi della Santa Sede c del Santo Padre. Era in questo spirito che aveva espresso il suo parere sui gesuiti.
Anche la romanità aveva difficoltà a digerire la bomba delle minacce politiche e finanziarie che «Stato» aveva deciso di mettere sul tavolo.
A «Propaganda», con la franchezza che lo contraddistingueva, sembrava ora di cambiare. Sembrava ora, disse in modo disarmante, di discutere di qualcosa che lui potesse capire meglio degli intrighi della politica dell’Europa orientale o dei rapporti tra i gesuiti e i marxisti. Di discutere quello che stava succedendo in quella parte di Chiesa affidata alle sue cure: le terre di missione in Africa e in Asia.
«Propaganda» aveva preparato per tempo il suo rapporto; una copia si trovava in ciascuna delle cartellette di damasco e aveva potuto essere letta con comodo prima della riunione. Il rapporto, che riassumeva brevemente, entrava penosamente nei dettagli di come i missionari gesuiti che lavoravano in India fossero avanzati sulla strada dell’adulterazione della fede cristiana. Il riassunto di «Propaganda» toccò solo il significato deformato del sacerdozio, del battesimo, del sacramento dell’Eucarestia e del primato e dell’autorità del Santo Padre sulla Chiesa, così come venivano in segnati dai gesuiti in India. Parlò dello stemperamento in forme irriconoscibili delle convinzioni cristiane fondamentali sull’immortalità, il cielo e l’inferno, il valore della preghiera, della mortificazione e della penitenza, il significato della messa e della salvazione.
Le osservazioni erano più allarmanti proprio perché «Propaganda» non sembrava perseguire interessi personali. La sua era un’unica domanda: perché? Perché i gesuiti avevano adulterato e deformato anche le più sacre delle convinzioni cristiane? Era cosciente che i gesuiti parlavano di se stessi in termini «d’inculturazione» e «indigenizzazione». Ma il risultato era una costante e organizzata decristianizzazione di quella che era stata in India una florida comunità cristiana di tre milioni di anime.
«Propaganda» si diede la risposta con lo stesso tono pacato con cui aveva posto la domanda. In India i gesuiti erano diventati quello che erano perché avevano continuato, con i loro superiori a Roma, a seguire gli insegnamenti del confratello Pierre Teilhard de Chardin.
De Chardin, nonostante la Santa Sede lo avesse condannato nel 1960 insieme con i suoi scritti, era stato per anni il beniamino degli intellettuali gesuiti. Gli scritti di quell’uomo — «Propaganda» ricordò ai venerabili colleghi le parole della condanna ufficiale — «furono fonte di ambiguità, anzi di gravi errori che offendono la dottrina cattolica». Non c’era da meravigliarsi quindi che i gesuiti, continuando a seguire la stella di de Chardin, si mettessero contro gli interessi della Chiesa. Insomma, «Propaganda» concordava sia con la condanna del 1960 di de Chardin sia con le accuse mosse all’intera Compagnia dai papa nel 1981.
All’inizio sembrò che «Clero» intendesse limitarsi a ribadire il legame indicato da «Propaganda» tra l’opera di Teilhard de Chardin e l’attività attuale dei gesuiti. Come mai la facoltà di teologia e di filosofia del Centro Sèvres di Parigi avrebbe organizzato per il prossimo 13 giugno celebrazioni in onore del centenario della nascita di de Chardin? Secondo le informazioni di «Clero», ciò avveniva con la benedizione degli istituti pontifici a Roma e l’approvazione del segretario di Stato e del generale dell’Ordine.
Il suggerimento di «Clero» fu che gli interessati avrebbero fatto meglio a offrire delle messe per l’anima di de Chardin invece di disquisire su quanto cera di buono e di cattivo nel suo pensiero ambiguo e nelle sue teorie vaghe e pericolose. La proposta di Sua Santità fu più precisa. Il pontefice era sicuro che «Stato» avrebbe comunicato a padre Arrupe che la Santa Sede disapprovava le celebrazioni previste.
«Clero» aveva però ancora un paio di domande. A proposito di un rapporto arrivato in Vaticano un anno e mezzo prima, nell’ottobre del 1979. Il venerabile fratello cardinale Vincente Scherer di Porto Aiegre, in Brasile, si era diffuso sul Colegio Anchieta dei gesuiti di quella città. Secondo Scherer, in quel collegio si usavano libri di testo marxisti, agli studenti venivano inculcati princìpi marxisti e i sacramenti della comunione e della confessione venivano derisi come anacronistici. Che ne era stato, si chiedeva «Clero», di quel rapporto? Il Colegio aveva continuato allegramente nei suoi metodi. Perché padre Arrupe non aveva corretto quei gravi errori?
E poi, continuò a chiedersi «Clero» ad alta voce, cera lo strano caso del padre gesuita Caprile, che scriveva nella rivista ufficiale dei gesuiti, Civiltà cattolica, pubblicata a Roma. L’oggetto di Caprile era la proibizione cattolica, sotto pena di scomunica, di appartenere a una loggia. La scomunica era lettera morta. Caprile poteva scrivere il suo articolo e l’appartenenza a una loggia era aperta a ogni cattolico. Ciò significava minare apertamente le decisioni del papa a proposito della morale. Come mai Caprile poteva pubblicare cose del genere e godere dell’impunità e della benedizione del padre generale?
Le domande di «Clero» erano indirizzate in particolare a «Stato». L’alleanza tra il cardinale segretario e Civiltà cattolica era un dato di fatto. Era inoltre risaputo che «Stato» si era appropriato del rapporto del cardinale Scherer e lo aveva insabbiato.
«Dottrina» trovò che il momento era appropriato per annodare alcuni fili. Non era solo a Roma, in America Latina o in India che succedevano cose strane con i gesuiti al centro. Nelle cartellette di damasco rosso davanti alle loro eminenze c’erano pagine e pagine su gesuiti che insegnavano, predicavano e agivano in un modo non solo deviarne, ma che contraddiceva sia gli insegnamenti dottrinali della Chiesa sia l’esplicito punto di vista di Sua Santità su numerose questioni essenziali.
«Dottrina» si offrì di ritrovare in quelle pagine una dozzina di nomi d’importanti gesuiti europei, più di due dozzine di gesuiti americani, almeno venticinque latino-americani e più o meno un’altra decina per ciascuno dei seguenti paesi: India, Giappone, Filippine, Irlanda e Inghilterra. L’unico filo che sembrava unire tutti era la convinzione di dover appoggiare «la lotta di classe». Se ciò non era marxismo, allora «Dottrina» non conosceva il significato del termine. Se un fenomeno così generalizzato non aveva la sanzione ufficiale sia del padre generale sia degli altri superiori, allora «Dottrina» non capiva il meccanismo di funzionamento dell’Ordine dei gesuiti. Per quanto lo riguardava, «Dottrina» concluse, le cose erano andate troppo in là. Il Santo Padre avrebbe dovuto agire con decisione. Subito.
«Dottrina» si offrì di ritrovare in quelle pagine una dozzina di nomi d’importanti gesuiti europei, più di due dozzine di gesuiti americani, almeno venticinque latino-americani e più o meno un’altra decina per ciascuno dei seguenti paesi: India, Giappone, Filippine, Irlanda e Inghilterra. L’unico filo che sembrava unire tutti era la convinzione di dover appoggiare «la lotta di classe». Se ciò non era marxismo, allora «Dottrina» non conosceva il significato del termine. Se un fenomeno così generalizzato non aveva la sanzione ufficiale sia del padre generale sia degli altri superiori, allora «Dottrina» non capiva il meccanismo di funzionamento dell’Ordine dei gesuiti. Per quanto lo riguardava, «Dottrina» concluse, le cose erano andate troppo in là. Il Santo Padre avrebbe dovuto agire con decisione. Subito.
«Religiosi» fece un altro tentativo di arrivare a una conclusione favorevole ai gesuiti. Era certo che si trattava di un equivoco. Padre Arrupe aveva riconosciuto che la Compagnia di Gesù era cambiata dopo il Concilio Vaticano II. Aveva anche fornito dei buoni motivi per quel cambiamento: era la Chiesa ad essere cambiata. Con il concilio i cattolici erano arrivati a rendersi conto che la Chiesa è «il popolo di Dio», non un corpo gerarchico. Paolo VI aveva fatto propria questa nuova visione della Chiesa, questa nuova ecclesiologia. Teologi e vescovi avevano adottato con entusiasmo il nuovo punto di vista. I gesuiti, come i vescovi, non facevano che ascoltare la voce del «popolo di Dio». I loro nemici li accusavano naturalmente di essere marxisti; ma in realtà essi non erano che campioni del nuovo concetto di «Chiesa».
«Religiosi» si rendeva conto che in aree isolate della Chiesa, come in Polonia, le nuove idee di cosa fosse in realtà la Chiesa non erano ancora penetrate. Ma era solo questione di tempo. Sua Santità aveva partecipato attivamente al Concilio Vaticano; come avevano partecipato «Dottrina», «Clero» e «Vescovi». Avevano accettato il nuovo concetto di Chiesa. Perché i gesuiti dovevano essere rimproverati di seguirne gli insegnamenti? Solo i loro nemici, «Religiosi» ribadì il suo punto di vista, potevano scambiare l’interesse dei gesuiti per «il popolo di Dio» per un’adesione alla «lotta di classe» marxista.
Tornando a invocare il Concilio Vaticano III, «Religiosi» era tornato a invadere l’area di competenza di «Dottrina».
«Dottrina» ringraziò il Venerabile fratello per avergli chiarito l’idea chiave che muoveva la Compagnia di Gesù di padre Arrupe. La difficoltà tuttavia era che i gesuiti e molti vescovi sembravano aver dimenticato cosa aveva detto il Concilio Vaticano II a proposito del «popolo di Dio»; cioè che quel «popolo» doveva essere guidato non dall’istinto o dalle teorie sociali di Marx o di chiunque altro. A guidarlo dovevano essere la dottrina e la legge morale del pontefice romano e dei vescovi in comunione col pontefice. Ecco che cosa avevano dimenticato i gesuiti e contro un’omissione così grave qualcosa doveva essere fatto.
Fu di nuovo «Stato» a intervenire nel duello tra «Dottrina» e «Religiosi». E tornò a ricordare ai presenti che già in precedenza aveva alzato la posta a proposito della decisione da prendere sui gesuiti.
Sì, si dichiarò d’accordo il segretario, è necessario fare qualcosa a proposito della situazione. Tutta la situazione. Era l’intera situazione della Chiesa che Sua Santità stava cercando di migliorare con i suoi viaggi apostolici e coll’esperimento polacco di Solidarnosc. Tuttavia, c’era il problema di quel patto fra Mosca e il Vaticano del 1962. E forse era meglio ricordare che anche quel patto del 1962 non era altro che il rinnovo di un patto precedente tra la Santa Sede e Mosca.
«Stato» si riferiva alle conversazioni avvenute nel 1942 sotto il regno di Pio XII. Fu in quell’anno che monsignor Giovanni Battista Montini, che sarebbe poi diventato papa col noma di Paolo VI, ebbe colloqui diretti con un rappresentante di Giuseppe Stalin. Quelle conversazioni avevano lo scopo di attenuare i fulmini costanti di Pio XII contro il dittatore sovietico e il marxismo. «Stato» aveva partecipato di persona a quei colloqui. Era stato presente anche a una conversazione tra Montini e il leader del partito comunista italiano Palmiro Togliatti nel 1944.
Se i venerabili colleghi lo credevano opportuno, «Stato» Poteva fornire sull’avvenimento i rapporti dell’ufficio dei servizi strategici alleati, a partire con il rapporto JR-1022 del 28 agosto 1944. Ovviamente «Stato» aveva controllato nei Particolari le sue informazioni prima di arrivare alla riunione, aspettandosi di trovarsi di fronte un’opposizione organizzata.
L’informazione di «Stato» sembrò preoccupare Giovanni Paolo II che si informò se Sua Santità Pio XII era stato al corrente di quelle conversazioni e accordi. No, «Stato» ammise. Ma restava il fatto che qualcuno deve occuparsi delle cose sgradevoli. Qualche volta i subordinati devono agire all’insaputa dei loro superiori per favorire proprio i progetti dei superiori stessi. Naturalmente i patti tra Mosca e il Vaticano del 1942, 1944 e 1962 erano un affare interno alla Santa Sede. Proprio come le conversazioni e gli accordi che in quel momento Sua Santità stava conducendo con l’amministrazione americana.
Allo stesso modo i gesuiti cercavano di far fronte a una realtà sociale e politica. Non potevano essere tacciati di essere marxisti. Era un’espressione del fermento della Chiesa. Una espressione preziosa.
Di nuovo «Stato» aveva espresso la sua opinione indirettamente, senza fare critiche personali a Giovanni Paolo II. Secondo molti, trattare con gli americani era altrettanto male che trattare con i marxisti sovietici. Ciascuno faceva ciò che riteneva meglio. I gesuiti operavano in situazioni dove i comunisti erano già aggressivi. Forse il loro metodo era accettabile come tanti altri.
«Stato» si affrettò ad aggiungere, tuttavia, che si dovevano correggere gli abusi. Certamente, padre Arrupe e gli altri dirigenti gesuiti avrebbero messo ordine nella loro casa quando si fossero riuniti a Roma per la prossima Congregazione generale. Erano già in corso intensi preparativi. Attendendo pazientemente, era l’opinione di «Stato», tutto si sarebbe messo a posto. L’ultima cosa di cui avevano bisogno infatti erano ulteriori lacerazioni. «Stato» aveva ripetuto la sua offerta di compromesso e aveva rinnovato la sua minaccia.
La duplice possibilità era l’esca perfetta per costringere «Vescovi» a entrare nella discussione. Le sue uniche preoccupazioni erano quelle dell’uomo di buona volontà. Dopo tutto, la soppressione generale dei gesuiti avrebbe creato una quantità di vuoti insostenibili nei collegi, nei seminari, nelle missioni, nelle università e negli istituti. Su molti vescovi sarebbe ricaduto il compito di trovare nuovo personale. E ciò avrebbe vittimizzato molti eccellenti gesuiti che svolgevano fedelmente il loro compito e difendevano pubblicamente la Chiesa e il papato. Ciò di cui Sua Santità aveva bisogno era una riforma della Compagnia. E certamente, come «Stato» aveva detto, sarebbe stato meglio che le cose seguissero un loro corso costituzionale. Che l’Ordine si riunisse per la Congregazione generale. Una volta che i capi fossero riuniti a Roma, Sua Santità avrebbe avuto i mezzi giuridici per intervenire, per indurli a una riforma. Se fosse stato necessario, padre Arrupe si sarebbe potuto dimettere. Come aveva detto «Stato», con pazienza tutto si sarebbe aggiustato.
«Dottrina» non era per niente soddisfatto della mediazione di «Vescovi». Papa Paolo VI, fece notare, il cui nome era stato invocato molte volte nel corso della discussione per giustificare i gesuiti, aveva tentato due volte di riformare la Compagnia proprio con i mezzi suggeriti da «Vescovi» e «Stato». Entrambe le volte aveva fallito. La situazione chiedeva un intervento più significativo.
Cosa intendeva, chiese «Stato», «Dottrina» con «un intervento più significativo»? «Dottrina» si espresse chiaramente: un’azione a due tempi. Primo, accettare le «dimissioni» di padre Arrupe. Secondo, nominare un supervisore papale che si occupasse della preparazione di una riforma veramente efficace nel corso della prossima Congregazione generale.
Come succede di solito in riunioni del genere, si era arrivati a quel punto in cui entrambe le parti avevano capito che il male peggiore poteva non essere accettare una vittoria parziale. «Dottrina» aveva esordito con la speranza nella soppressione totale della Compagnia. «Stato» aveva sostenuto il laissez-faire. L’azione a due tempi proposta da «Dottrina» era un compromesso per entrambi. Per il momento era il massimo che entrambi gli avversari potevano sperare di ottenere.
Si fece silenzio. Giovanni Paolo II guardò brevemente un cardinale dopo l’altro. Tutti assentirono. Il segretario di Stato fu quello che il papa guardò più a lungo. Alzandosi per uscire dalla sala il papa fece solo un commento: «Bene, ci sono voluti otto ballottaggi perché i cardinali mi eleggessero papa!».
Nessuno sapeva come interpretare quel commento. Era una battuta ironica? Oppure il richiamo al rispetto dovuto alla persona del papa? O l’avvertimento che poteva trovare abbastanza appoggio tra i cardinali per scavalcare «Stato» e chiunque altro nella questione dei gesuiti? Dopo tutta quella romanità, quel papa che era, come aveva avuto a dire, «venuto da un paese molto lontano», dove aveva imparato a scambiare colpi pesanti col drago marxista, era riuscito a finire la riunione su una nota inquietante per i suoi cardinali ministri.

Pedro Arrupe (destra) con Henri de Lubac (centro) e Karl Rahner (sinistra), esponenti della “nouvelle theologie”.
Una cosa tuttavia era certa. Molto presto padre Arrupe avrebbe avuto notizia della riunione. Avrebbe saputo tutto ciò che era stato detto. Avrebbe saputo che il Santo Padre non era né un Paolo VI che la debolezza rendeva flessibile, né un Giovanni XXIII che le speranze visionarie rendevano cieco alle macchinazioni dei subordinati. Avrebbe saputo che per il momento l’attacco frontale contro l’Ordine era stato evitato, non per amore di Arrupe o per stima della Compagnia, ma perché ciò faceva comodo alla politica attuale del segretario di Stato e alle ambizioni personali di «Religiosi» e «Vescovi».
Attacco frontale o no, comunque. Arrupe, il papa nero, era altrettanto realista di Wojtyla, il papa bianco.





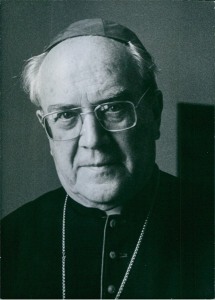





Wojtyla: modernista.
RispondiEliminaSedicenti "gesuiti" conciliabolari: modernisti.
Nessuno di costoro ha a che fare con i Papi ed i santi veri Gesuiti cattolici della storia della Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica ed assolutamente non ereticomodernista.
Basta calunniare i veri Gesuiti cattolici prendendo spunto dagli eretici attuali sedicenti tali e copiando autori stracondannati come ad esempio Pascal o Gioberti; la calunnia è peccato grave, Deus non irridetur.
gne gne
Elimina