App Immuni: guerra al virus o Grande Fratello?
Cari amici di Duc in altum, circa l’app Immuni, che sta facendo molto parlare di sé, ho ricevuto due lettere che vi propongo. Arrivano da due lettori affezionati del blog: il primo si firma, l’altro ha preferito restare anonimo.
***
Un’app voluta dalla propaganda di regime
Caro Valli, lanciata il 1° giugno, spopola la app Immuni, già la più scaricata, come informano i media gongolanti per il senso di responsabilità dimostrato dagli italiani. Ovviamente il garante della privacy giura che la segretezza è tutelata. In realtà è un sistema di tracciamento che farà sapere sempre a lorsignori dove sei, con chi sei, dove vai, che abitudini hai eccetera.
Il malcapitato italiano la scarica perché gli hanno bombardato il cervello dicendogli che ne beneficerà la salute propria e altrui. Ma è così? Assolutamente no. Dal punto di vista sanitario l’app non serve a niente (tranne che ad alimentare la peraltro già egemone psicosi da Covid), poiché:
- il Sars-CoV-2 è “clinicamente morto” (Zangrillo dixit, e lo conferma qualsiasi medico che non menta);
- come il professor Tarro ha ripetuto mille volte e come ha mostrato il dottor Bacco (“aumentando di pochi gradi centigradi la temperatura dei terreni di coltura e quindi portandola all’intervallo di 25-30 gradi, circa il 53% dei ceppi non sopravvive e il restante dimostra un’attività circa dodici volte inferiore”), d’estate, come tutti i coronavirus parenti suoi, il Sars-CoV-2 o muore o perde gran parte della sua carica virale
- se (e sottolineo: se) il Sars-CoV-2 dovesse ripresentarsi, con il calo della temperatura, ad autunno inoltrato, non farà danni rilevanti, poiché a) troverà una popolazione già largamente immunizzata; b) i medici sanno ormai come si cura e si guarisce a domicilio e quindi non saranno colti alla sprovvista.
Ma allora, perché mai scaricare l’app? Perché la propaganda di regime vuole così.
Alessandro Martinetti
***
Ma vogliono tracciare il virus o i cittadini?
Si parla ormai da tempo di tracciamenti (e anche già si fanno) attraverso app apposite per verificare se le persone che si spostano e si incrociano, per le strade o nei negozi o in qualunque altro luogo, sono o no positive al coronavirus. Uno degli epidemiologi più noti in Italia ha recentemente affermato, a proposito di una di queste applicazioni che dev’essere adottata nella Regione Puglia: “Ho studiato bene come funziona la app Immuni e sinceramente vi consiglio di non scaricarla se non siete interessati a sapere di essere entrati in contatto con un soggetto positivo al coronavirus, potenzialmente contagioso, e non avete a cuore la vostra salute e quella di chi è vicino. In tutti gli altri casi, usatela”.
Vale la pena esaminare brevemente gli impliciti contenuti in questa dichiarazione.
1) Uno specialista in malattie epidemiche dice di aver studiato bene un sofisticato dispositivo informatico e vuol farci intendere che è in grado di capire come davvero funziona, per esempio nel garantire la privacy dei cittadini e anche nell’efficacia del suo effettivo funzionamento. Viene da chiedersi: questo specialista in virus forse ha anche una laurea in informatica, con un master sui sistemi di tracciamento, per poter dare garanzie e assicurazioni sul dispositivo in questione?
2) Il suo modo di proporre l’adozione dell’applicazione insinua la stupidità di chi decide di non applicarla: cioè solo gli incoscienti che non hanno a cuore la propria e l’altrui salute. Neanche lo sfiora il pensiero che i minimi spostamenti del cittadino siano registrati, come peraltro già lo sono quelli di chiunque porta indosso uno smartphone. Si potrebbe domandare allo scienziato: lei desidera portare permanentemente un bracciale magnetizzato simile a quello di chi sta in libertà vigilata? Lo usi lei, allora, ma non lo proponga come misura cautelare di massa.
3) Naturalmente non si affronta neppure il problema a monte: come si fa a sapere se uno è positivo e potenzialmente contagioso e segnalarlo attraverso una app? È possibile solo previo tampone. Una piccola domanda che allora sorge è: quanti tamponi ha fatto fino ad ora la Puglia? A quanto è dato sapere alcune decine di migliaia su ben quattro milioni di abitanti. A cosa serve dunque questa app? A tracciare il virus o i cittadini?
4) Ci dica l’esperto in questione: ha intenzione di promuovere i tamponi a tappeto? Anche su scala nazionale? Se è così, allora cominci subito, chiedendo uno stanziamento di qualche milione di euro per quattro milioni di tamponi e attendiamo che l’operazione termini (un anno? due anni? In ogni caso a fine Covid).
5) Il problema è che quando saranno stati fatti quattro milioni di tamponi bisognerà ricominciare da capo, perché chi è negativo oggi può essere positivo fra una settimana e viceversa. Ci ha mai pensato l’illustre scienziato? Un “tamponamento” continuo, fino all’esaurimento, per sapere in tempo reale tutti gli aggiornamenti sanitari di quattro milioni di abitanti. Senza contare i falsi positivi e i falsi negativi. E quanto uno è stato registrato come positivo e contagioso, come deve fare per farsi cancellare dal lazzaretto virtuale, se poi il virus “gli passa”? E fino a quando dovrebbe durare questo tamponamento? Fino alla fine degli asintomatici? La fantasia non ha davvero limiti. Ma cosa c’entra la fantasia con la scienza?
Queste osservazioni, è evidente, valgono per tutte le regioni e per l’intero territorio nazionale, anzi per tutto il mondo. Sembra che gli unici che possono rallegrarsi di simili prospettive siano i produttori delle app e chi ha interesse a monitorare la vita privata delle persone.
Lettera firmata
LE PAROLE DI ZANGRILLO
Virus sparito, l'imprevisto che turba l'establishment
Il professor Zangrillo ha detto che l’epidemia “clinicamente non esiste più”: significa che l’epidemia ha già completato il suo ciclo. Affermazione dimostrata dalla realtà dei fatti. A dare più fastidio all’establishment sono state le parole sulle misure coercitive in atto che «terrorizzano il Paese».
Tanto rumore per nulla; anzi: per una chiara evidenza clinica che tuttavia non si vuole riconoscere. È il caso scatenato dalle affermazioni del professor Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, per il quale “il Covid non esiste più”, come hanno riportato gli organi di stampa, dando vita ad una dura polemica nei confronti del dirigente medico da parte degli esponenti del Comitato Tecnico Scientifico, che l’hanno accusato di irresponsabilità. In pratica il professore è stato bollato come “negazionista”, un termine infamante che è cominciato a circolare e ad essere utilizzato nei confronti di chi cerca di leggere in un’ottica diversa dalla vulgata ufficiale di Stato l’epidemia di Coronavirus.
In realtà, il professor Zangrillo ha detto una cosa un po' diversa da quella su cui i virologi da bar si stanno accapigliando sui social: ha detto che l’epidemia “clinicamente non esiste più”. Questa è una affermazione dimostrata dalla realtà dei fatti. Nell’Ospedale di Lecco, nella Lombardia zona rossa per eccellenza, in terapia intensiva non entra un paziente da un mese, dal 1° maggio. Zangrillo, che è un primario operativo, che dirige un dipartimento di emergenza, non ha fatto che mettere in evidenza quello che è sotto anche i suoi occhi da settimane: non solo sono diminuiti i casi, ma è diminuita e di molto la loro gravità. Il merito? Anche di quelle terapie osteggiate in ogni modo delle quali la Nuova BQ ha già parlato, di un miglioramento dell’assistenza territoriale dove i medici di medicina generale prestano cure a domicilio, e infine di una possibile diminuzione dell'aggressività e della virulenza del Covid stesso, favorita anche dall’aumento delle temperature e dall’avvicinarsi dell’estate.
Ma forse a dare più fastidio all’establishment governativo sono state le parole di commento del professore alle misure coercitive ancora in atto e ai provvedimenti legislativi vigenti e annunciati: “Terrorizzare il Paese è qualcosa di cui qualcuno si deve prendere la responsabilità”. Hanno preso cappello il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, che ha parlato di affermazioni “sconcertanti”, il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa che dice che è "un messaggio sbagliato che rischia di confondere gli italiani", e un altro componente del Comitato, lo pneumologo Luca Richeldi.
In realtà, che il virus circoli ancora, che si riscontrino ancora casi, ricoveri e decessi, è innegabile. Ma se Zangrillo non fa che evidenziare un dato numerico, che è palese, è altrettanto vero che anche la carica virale del Covid rispetto a marzo è mutata, ed è diminuita. Lo affermano studiosi come il professor Clementi o il virologo Guido Silvestri, che ha in corso di pubblicazione degli studi al riguardo.
Quello che sta emergendo non fa che confermare le previsioni degli epidemiologi che ben conoscono l’andamento di questo tipo di epidemie virali. I Coronavirus - e questo lo sappiamo bene e da tempo - sono dei virus stagionali. Sono legati alle condizioni climatiche dell’autunno e dell’inverno, come i virus influenzali, come la SARS del 2002, causata come noto da un Coronavirus il cui genoma era all’80% sovrapponibile a quello del Covid-19, che ebbe inizio nell’ottobre del 2002 e nel giugno del 2003 si era completamente estinto, per non tornare più.
Dobbiamo dunque aspettarci un andamento simile per il Covid. Ma la tanto paventata “seconda ondata”, quella che il Comitato Tecnico e il ministro Speranza continuano a usare come minaccia-fantasma per poter prorogare le misure coercitive, per introdurre imposizioni discutibili come l’obbligo di mascherine per bambini?
È chiaro che questa minaccia serve soprattutto - come ha sottolineato il professor Zangrillo - per mantenere la gente in uno stato di paura, di insicurezza, sotto ricatto per tutte le limitazioni alle libertà individuali che possono essere imposte.
Riguardo alla sedicente seconda ondata, un'ipotesi che ci sentiamo di sostenere è che di fatto c’è già stata. Abbiamo già dato. Per capire: l’epidemia del Covid ha avuto due momenti: il primo, iniziato già a dicembre e proseguito a gennaio, con una casistica limitata, asintomatica o paucisintomatica, che ha colpito soggetti in buona parte sani e in giovane età. Questa è stata di fatto la prima ondata, non riconosciuta. Poi, il secondo momento, quello drammatico iniziato ai primi di marzo con un'impennata della curva epidemica, l’esplosione dei casi, soprattutto tra soggetti anziani, fragili, a rischio.
Si potrebbe dunque concludere che l’epidemia ha già completato il suo ciclo. Il virus sparirà non solo dalle terapie intensive, ma anche dalla casistica. O meglio: diventerà una patologia gestibile, curabile, guaribile. Anche in vista di nuovi casi nel prossimo autunno, eventualità che secondo i soloni del Comitato scientifico è probabile, ma che in realtà è solo un’ipotesi come altre e che non ha riscontro in tutti i precedenti epidemiologici.
Paolo Gulisano
https://lanuovabq.it/it/virus-sparito-limprevisto-che-turba-lestablishment
Virus sparito, l'imprevisto che turba l'establishment
Il professor Zangrillo ha detto che l’epidemia “clinicamente non esiste più”: significa che l’epidemia ha già completato il suo ciclo. Affermazione dimostrata dalla realtà dei fatti. A dare più fastidio all’establishment sono state le parole sulle misure coercitive in atto che «terrorizzano il Paese».
Tanto rumore per nulla; anzi: per una chiara evidenza clinica che tuttavia non si vuole riconoscere. È il caso scatenato dalle affermazioni del professor Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, per il quale “il Covid non esiste più”, come hanno riportato gli organi di stampa, dando vita ad una dura polemica nei confronti del dirigente medico da parte degli esponenti del Comitato Tecnico Scientifico, che l’hanno accusato di irresponsabilità. In pratica il professore è stato bollato come “negazionista”, un termine infamante che è cominciato a circolare e ad essere utilizzato nei confronti di chi cerca di leggere in un’ottica diversa dalla vulgata ufficiale di Stato l’epidemia di Coronavirus.
In realtà, il professor Zangrillo ha detto una cosa un po' diversa da quella su cui i virologi da bar si stanno accapigliando sui social: ha detto che l’epidemia “clinicamente non esiste più”. Questa è una affermazione dimostrata dalla realtà dei fatti. Nell’Ospedale di Lecco, nella Lombardia zona rossa per eccellenza, in terapia intensiva non entra un paziente da un mese, dal 1° maggio. Zangrillo, che è un primario operativo, che dirige un dipartimento di emergenza, non ha fatto che mettere in evidenza quello che è sotto anche i suoi occhi da settimane: non solo sono diminuiti i casi, ma è diminuita e di molto la loro gravità. Il merito? Anche di quelle terapie osteggiate in ogni modo delle quali la Nuova BQ ha già parlato, di un miglioramento dell’assistenza territoriale dove i medici di medicina generale prestano cure a domicilio, e infine di una possibile diminuzione dell'aggressività e della virulenza del Covid stesso, favorita anche dall’aumento delle temperature e dall’avvicinarsi dell’estate.
Ma forse a dare più fastidio all’establishment governativo sono state le parole di commento del professore alle misure coercitive ancora in atto e ai provvedimenti legislativi vigenti e annunciati: “Terrorizzare il Paese è qualcosa di cui qualcuno si deve prendere la responsabilità”. Hanno preso cappello il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, che ha parlato di affermazioni “sconcertanti”, il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa che dice che è "un messaggio sbagliato che rischia di confondere gli italiani", e un altro componente del Comitato, lo pneumologo Luca Richeldi.
In realtà, che il virus circoli ancora, che si riscontrino ancora casi, ricoveri e decessi, è innegabile. Ma se Zangrillo non fa che evidenziare un dato numerico, che è palese, è altrettanto vero che anche la carica virale del Covid rispetto a marzo è mutata, ed è diminuita. Lo affermano studiosi come il professor Clementi o il virologo Guido Silvestri, che ha in corso di pubblicazione degli studi al riguardo.
Quello che sta emergendo non fa che confermare le previsioni degli epidemiologi che ben conoscono l’andamento di questo tipo di epidemie virali. I Coronavirus - e questo lo sappiamo bene e da tempo - sono dei virus stagionali. Sono legati alle condizioni climatiche dell’autunno e dell’inverno, come i virus influenzali, come la SARS del 2002, causata come noto da un Coronavirus il cui genoma era all’80% sovrapponibile a quello del Covid-19, che ebbe inizio nell’ottobre del 2002 e nel giugno del 2003 si era completamente estinto, per non tornare più.
Dobbiamo dunque aspettarci un andamento simile per il Covid. Ma la tanto paventata “seconda ondata”, quella che il Comitato Tecnico e il ministro Speranza continuano a usare come minaccia-fantasma per poter prorogare le misure coercitive, per introdurre imposizioni discutibili come l’obbligo di mascherine per bambini?
È chiaro che questa minaccia serve soprattutto - come ha sottolineato il professor Zangrillo - per mantenere la gente in uno stato di paura, di insicurezza, sotto ricatto per tutte le limitazioni alle libertà individuali che possono essere imposte.
Riguardo alla sedicente seconda ondata, un'ipotesi che ci sentiamo di sostenere è che di fatto c’è già stata. Abbiamo già dato. Per capire: l’epidemia del Covid ha avuto due momenti: il primo, iniziato già a dicembre e proseguito a gennaio, con una casistica limitata, asintomatica o paucisintomatica, che ha colpito soggetti in buona parte sani e in giovane età. Questa è stata di fatto la prima ondata, non riconosciuta. Poi, il secondo momento, quello drammatico iniziato ai primi di marzo con un'impennata della curva epidemica, l’esplosione dei casi, soprattutto tra soggetti anziani, fragili, a rischio.
Si potrebbe dunque concludere che l’epidemia ha già completato il suo ciclo. Il virus sparirà non solo dalle terapie intensive, ma anche dalla casistica. O meglio: diventerà una patologia gestibile, curabile, guaribile. Anche in vista di nuovi casi nel prossimo autunno, eventualità che secondo i soloni del Comitato scientifico è probabile, ma che in realtà è solo un’ipotesi come altre e che non ha riscontro in tutti i precedenti epidemiologici.
Paolo Gulisano
https://lanuovabq.it/it/virus-sparito-limprevisto-che-turba-lestablishment
Ammalarsi di paura. L’«effetto nocebo» dello #stareincasa e della malainformazione sul coronavirus
Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni
Wumingfoundation.com
[Sono trascorsi due mesi e mezzo da quando i giornali hanno dato la notizia del primo morto italiano per coronavirus, interrompendo la lunga serie di titoli dedicati a Renzi e alle liti di governo.
«Virus, il Nord nella paura», tuonava la prima pagina di Repubblica del 22 febbraio.
Da quel momento, i media italiani a reti unificate e la retorica dei governanti non hanno più smesso di ingigantire quella paura, di trasformarla in terrore, e soprattutto di renderla nociva.
Abbiamo a lungo ragionato sugli effetti e gli scopi di questa manipolazione delle nostre fobie, ma ancora non ci siamo soffermati a sufficienza sull’ipotesi che quei timori – ben comprensibili di fronte a una pandemia – siano diventati a loro volta un morbo, una patologia che s’è aggiunta al Covid19, abbassando le difese immunitarie della popolazione e rendendo il contagio più grave.
In svariati commenti ai post di queste settimane è emersa l’idea che l’esercito in strada, i toni dei ministri, la scelta e la presentazione dei dati, le homepage dei giornali abbiano contribuito a farci – letteralmente – ammalare di paura.
Questo articolo, scritto appositamente per Giap, affronta la questione dal punto di vista dell’antropologia medica e dello studio scientifico sull’effetto placebo e il suo contrario: l’effetto nocebo. WM]
«Virus, il Nord nella paura», tuonava la prima pagina di Repubblica del 22 febbraio.
Da quel momento, i media italiani a reti unificate e la retorica dei governanti non hanno più smesso di ingigantire quella paura, di trasformarla in terrore, e soprattutto di renderla nociva.
Abbiamo a lungo ragionato sugli effetti e gli scopi di questa manipolazione delle nostre fobie, ma ancora non ci siamo soffermati a sufficienza sull’ipotesi che quei timori – ben comprensibili di fronte a una pandemia – siano diventati a loro volta un morbo, una patologia che s’è aggiunta al Covid19, abbassando le difese immunitarie della popolazione e rendendo il contagio più grave.
In svariati commenti ai post di queste settimane è emersa l’idea che l’esercito in strada, i toni dei ministri, la scelta e la presentazione dei dati, le homepage dei giornali abbiano contribuito a farci – letteralmente – ammalare di paura.
Questo articolo, scritto appositamente per Giap, affronta la questione dal punto di vista dell’antropologia medica e dello studio scientifico sull’effetto placebo e il suo contrario: l’effetto nocebo. WM]
di Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni *[Deutsche Übersetzung hier.]
0. Il Covid-19 come macchina di visione
La migliore filosofia della nostra epoca lo insegna da anni: la grande partizione fra natura e cultura, fra regno dell’oggettività e regno dei desideri, non è che un costrutto moderno. Nell’impero del rilevamento e dei big data lo abbiamo (ri)scoperto a nostro danno: i fatti neutri non esistono; nessun dato è semplicemente “dato”, ogni dato è l’esito di una scelta osservativa, di un’interpretazione, di un’intenzione, di una politica. Non c’è visione del mondo che non sia frutto del convenire degli sguardi, delle attitudini, delle scelte consapevoli e inconsapevoli di una comunità; e non c’è cultura condivisa da un gruppo che non operi delle semplificazioni perché, come insegnano le scienze fisiche, il reale è troppo complesso per essere afferrato a partire da una sola prospettiva.
Finché tali semplificazioni non sono eccessive, quel mondo resta vivibile; se lo diventano, e non sono più in grado di “reggere” all’impatto dell’esperienza, si arriva a quella che Ernesto de Martino chiamava «apocalisse culturale», un soprassalto del reale che scompagina il quadro condiviso e mette a rischio la tenuta di quel mondo. Quando ciò accade, quel che si rivela non è il reale nella sua oggettività primigenia, ma una sorta di “buio epistemologico”, nel quale occorre navigare a vista con strumenti antichi.

Ernesto De Martino
È quanto possiamo osservare nell’emergenza Covid-19, vera e propria “macchina di visione” in grado di strapparci al sonno delle nostre convinzioni e rimetterci di fronte alla complessità del reale. Nella più grande crisi pandemica del dopoguerra, non abbiamo dati affidabili né sul numero di infettati, né sul numero di morti, né sugli effetti delle diverse misure di contenimento, né su quel che si prospetta per il prossimo futuro.
Prevedibile, in circostanze siffatte, una sorta di «nostalgia del semplice», il tentativo di spiegare un universo complesso in base a poche ipotesi elementari. Complottismo e letture paranoiche trovano qui la loro radice, come anche i richiami alla Scienza – e cioè allo scientismo – di raffinati intellettuali che, fino a ieri, si atteggiavano a pensatori critici. Hic Rhodus, hic salta: ora più che mai bisogna riaffermare che la realtà è enormemente complessa e può essere – parzialmente – afferrata solo attraverso un pensiero complesso. Attorno a questo nodo si giocheranno le possibilità di uscita intelligente dalla crisi; e, d’altro canto, la semplificazione della complessità è, da sempre, operazione reazionaria di dominio sulle coscienze.
Ottime analisi critiche della pandemia in corso, delle politiche di contenimento e dei loro effetti sociali sono già disponibili in rete e ad esse rimandiamo per la descrizione del campo critico all’interno del quale ci muoviamo, dai post pubblicati in questo blog agli interventi di Roberto Beneduce e del Collectif Malgré Tout. Il quadro che questi testi compongono è giustamente incompleto, non lineare, difficile da tenere insieme con uno sguardo solo e poco suscettibile al riduzionismo. Prospetta un intreccio di fattori causali, nessuno dei quali è sufficiente, da solo, a render conto dei fatti: vi si mescolano la ricerca microbiologica sul virus, i dati epidemiologici, le politiche di contenimento, le politiche nazionali, le rese dei conti fra capitale e lavoro salariato, lo sconcerto della popolazione, gli effetti di quarant’anni di neoliberismo sulle strutture della sanità pubblica e, più ampiamente, sulle catene biotiche ed ecologiche a livello mondiale, i livelli d’inquinamento, le scelte amministrative e politiche.
Qui vorremmo aggiungere solo un’ipotesi collaterale che, pur non modificando nella sostanza il quadro di riferimento, lo approfondisce in una direzione eterodossa. Alcuni dei bocconi che metteremo sul piatto sono amari: prima di presentarli, proponiamo quattro passaggi che delineano il contesto teorico nel quale l’ipotesi prende corpo e che la giustifica. Sappiamo, così facendo, di chiedere ai lettori uno sforzo di attenzione difficile in tempi concitati ed emergenziali come quelli che stiamo vivendo, ma indispensabile per restare nella complessità.
1. Primo passaggio. Breaking news dalle scienze della vita
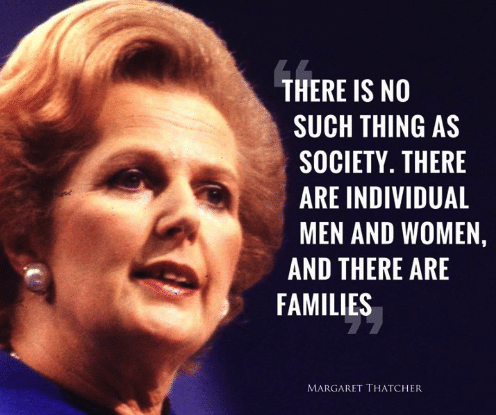 Entrambe lavoriamo da molti anni nella zona di confluenza fra antropologia medica, etnologia, etnopsicologia e geopolitica clinica e impieghiamo, nella lettura dei fenomeni, la teoria antropologica secondo cui gli umani sono frutto della loro storia. Niente di nuovo, per carità; ma dopo settant’anni di riduzionismo genetico, biologico ed ecologico e di enfasi neoliberista sull’individuo (Do you remember «there is no such thing as society»?), le prospettive che si aprono nel pensare gli umani come prodotti del loro tempo e delle circostanze che hanno attraversato sono davvero liberatorie.
Entrambe lavoriamo da molti anni nella zona di confluenza fra antropologia medica, etnologia, etnopsicologia e geopolitica clinica e impieghiamo, nella lettura dei fenomeni, la teoria antropologica secondo cui gli umani sono frutto della loro storia. Niente di nuovo, per carità; ma dopo settant’anni di riduzionismo genetico, biologico ed ecologico e di enfasi neoliberista sull’individuo (Do you remember «there is no such thing as society»?), le prospettive che si aprono nel pensare gli umani come prodotti del loro tempo e delle circostanze che hanno attraversato sono davvero liberatorie.
Non si tratta solo di wishful thinking da umanisti: tutta la ricerca genetica, evolutiva ed eto-ecologica degli ultimi vent’anni muove in questa direzione e indica che non solo gli umani, ma tutti i viventi sono enti molto più complessi di quel che pensavamo fino a poco tempo fa. Non derivano dallo sviluppo di un programma predefinito a livello di geni, ma sono l’esito di un’interazione continua e profondissima con l’ambiente, il paesaggio, i conspecifici, gli altri viventi.
Nel caso degli umani, questo significa che il tempo-spazio culturale nel quale prendiamo forma ci plasma secondo linee specifiche non solo in ciò che pensiamo, ma fin dentro le cellule, in un processo di vera e propria plasmazione bioculturale. Detto altrimenti, sono le ricerche scientifiche stesse, in questi anni, a mettere in discussione l’antica partizione cartesiana fra un corpo materiale, meccanico e oggettivo e una psiche immateriale: a ogni livello, i soggetti umani incorporano il loro mondo. La loro tenuta dipende dunque da una certa congruenza con il loro mondo e le transizioni richiedono tempo, sensibilità e intelligenza.
2. Secondo passaggio. Fra antropologia medica ed etnopsichiatria
Fra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, in parallelo con l’ultima grande stagione di lotte politiche, l’antropologia medica ha avuto una fioritura magnifica. Nata per studiare i sistemi terapeutici tradizionali e usata tatticamente per far capire agli “altri” – ai non occidentali o, se si preferisce, ai colonizzati – la superiorità della nostra medicina, alla fine della sua traiettoria essa è arrivata a interpretare anche la biomedicina come un sistema terapeutico tradizionale (quello della modernità industriale) e ha elaborato quadri epistemologici raffinati per leggere in modo complesso la salute, le malattie, la costruzione delle nosologie, le pratiche semeiotiche, l’efficacia, la compliance e via dicendo.
Si è notato, per cominciare, che l’idea e i modi della salute sono variabili e dipendono in via diretta dalla cosmovisione nella quale trovano posto. Non dappertutto la salute è intesa come “silenzio degli organi” o come “stato di benessere fisico, psichico e mentale”: altri mondi umani la intendono come equilibrio, oppure come flusso, o come giusta posizione rispetto agli assi cosmici o ancora come buona tenuta dei rapporti.
Nel frattempo la psichiatria transculturale, e in modo ancor più deciso l’etnopsichiatria, mettevano in discussione i manuali diagnostici degli psichiatri e teorizzavano che ogni gruppo umano impazzisce in modo specifico, sia mettendo in forma la sofferenza mentale in maniere differenti, sia predisponendo piste di crisi del tutto particolari e altrove sconosciute. Allo stesso modo, l’antropologia medica ha ipotizzato che ogni cultura plasmi non solo l’ideale di salute, ma anche i modi e le piste lungo le quali è possibile ammalarsi.
Arriviamo così al primo boccone difficile: in un quadro concettuale antropologicamente avvertito, neanche la malattia è qualcosa di dato e di universale, anch’essa è il prodotto di una storia in cui diversi fattori interagiscono in modi complessi. Le relazioni fra umani e ambiente; il clima; il tipo di cibo disponibile; la distribuzione del potere e delle risorse; il rapporto con la vita e con la morte; le pratiche igieniche e rituali; la definizione di salute e le tecniche per mantenerla; le descrizioni delle malattie; le tecniche di cura: tutto questo, e molto altro ancora, influisce sui modi in cui ci ammaliamo e sulle vie possibili per la guarigione.
3. Terzo passaggio. Cosmovisione, credenza, placebo, nocebo.

Robert A. Hahn
Nel 1983 Robert Hahn e Arthur Kleinman pubblicano sul prestigioso Medical Anthropology Quarterly un breve articolo sugli effetti della credenza. Nel richiamare fenomeni “etnologici” che cominciavano a essere riconosciuti anche dentro i nostri confini (le guarigioni per fede, l’effetto placebo/nocebo, l’efficacia simbolica ecc.), gli autori aprono senza mezzi termini:
«Le credenze uccidono; le credenze guariscono. Ciò che una persona crede all’interno di una società gioca un ruolo significativo tanto nel produrre malattia quanto come rimedio» (p. 3).
Nei decenni seguenti, Kleinman diventerà una delle massime autorità della psichiatria transculturale e Hahn, coordinatore di un centro di controllo e prevenzione delle malattie, approfondirà le sue ricerche sull’effetto nocebo. L’anno di pubblicazione rimanda agli ultimi scampoli di un periodo in cui, anche nella ricerca scientifica, era possibile inseguire ipotesi eterodosse:
«La portata di queste credenze come causa di malattie e come cura è la stessa dei microorganismi e dei farmaci: date determinate condizioni dell’organismo ospite e dell’ambiente, patologia o guarigione dipendono in modo consistente dalla credenza» (p. 3).
La loro tesi è sostenuta dalla letteratura etnologica, dalle loro stesse osservazioni e dalla ricchezza del sottofondo teorico emerso, in occidente, da due decenni di lotte, resistenze e sperimentazioni. In seguito le ricerche, i dati e gli esperimenti sull’effetto placebo si moltiplicheranno, confermando sostanzialmente le ipotesi dei due autori, ma le interpretazioni pubbliche resteranno sempre molto caute, come se vi fosse, nella stessa possibilità dell’effetto placebo/nocebo, qualcosa di troppo scandaloso per poter essere detto ad alta voce.
In effetti, ci sono antichi equivoci da sciogliere. Il primo dipende dalla nostra propensione ideologica all’estremismo: sostenere l’efficacia di ciò che è immateriale non significa negare l’efficacia di ciò che è materiale:
«È improbabile che la credenza nelle virtù terapeutiche dell’arsenico in dosi massicce trasformi questa sostanza chimica in un agente di guarigione; nondimeno suggeriamo – anche se non proveremo a dimostrarlo – che una simile credenza ne ridurrebbe l’effetto tossico. Allo stesso modo, l’assenza di fede negli antibiotici può diminuirne la potenza, e la fiducia o lo scetticismo circa pratiche o materie “farmacologicamente inerti” può indirizzarne l’effetto nella direzione attesa» (p. 18).

Il bel René
Il secondo equivoco viene dalla permanenza del modello cartesiano, cioè dalla separazione tra psiche e materia: in questo dualismo, l’effetto placebo/nocebo risulta “magico” nel senso deteriore di «pensiero magico», plagio o superstizione («se penso che guarirò, guarirò», «se un gatto nero mi attraverserà la strada, l’auto sbanderà»).
Per contro, il paradigma antropologico della plasmazione bioculturale richiede un’ontologia non cartesiana:
«Gli eventi umani non sono solo o mentali o fisici, per cui non ci si può chiedere come gli eventi mentali causino eventi fisici e viceversa. Semmai, tutti gli eventi umani hanno aspetti fisici e aspetti mentali (e altri aspetti ancora: chimici, fisiologici, consci, inconsci ecc.). La mente è incorporata, il corpo è consapevole. Reciprocamente, quando parliamo di “stati mentali” (credenze o aspettative, speranzose o spaventate), ci sono dei correlati fisiologici di questi stati» (p. 18).
Gli assunti fondamentali di una collettività si fanno corpo, cellule, fisiologia, neurologia; non di verità astratte o di pensieri disincarnati viviamo e moriamo, ma della nostra intima, radicale congruenza a un mondo.
4. Quarto passaggio. Nocebo vortex.
L’ultimo passaggio va a ritroso: comincia da un lungo articolo di Robert Hahn sull’effetto nocebo, pubblicato nel 1999, e termina con il celebre articolo di Walter Cannon sulle morti per choc, pubblicato nel 1942.
Dopo aver definito l’ipotesi nocebo come il fatto che «aspettarsi la malattia aumenta la probabilità che la malattia attesa si presenti» (p. 335), Hahn procede a una rassegna della letteratura scientifica disponibile e illustra diverse forme dell’effetto nocebo, di cui qui proponiamo solo un riassunto con qualche esempio.
C’è, per cominciare, lo sviluppo dei sintomi negativi attesi. In un esperimento viene detto a un gruppo di studenti che la somministrazione di una scossa elettrica causa mal di testa; sebbene la scossa non venga materialmente applicata, nelle ore seguenti il 70% di loro riporta il sintomo atteso. Certe allergie e la nausea anticipatoria dei pazienti in chemioterapia si possono ascrivere a un effetto di questo genere. Lo sviluppo sintomatico può avvenire anche osservando le reazioni di altri: si parla, in questo caso, di malattia sociogenica – un esempio di timbro leggero: il «colpo d’aria» è una malattia etnospecifica italiana, sconosciuta oltralpe e di cui i francesi ridono molto.
In assenza di eventi o comunicazioni specifiche, le convinzioni influenzano gli esiti: il timore di essere affetto da una malattia cardiaca aumenta il rischio di attacco ischemico; analogamente, gli stati depressivi – ovvero un senso generalizzato di impotenza – aumentano la probabilità di morte a seguito di eventi ischemici, a riprova del fatto che l’effetto nocebo non è affatto una “fisima” psicologica e i suoi effetti sono del tutto reali. Le cosiddette «morti voodoo», che si verificano a seguito dell’induzione di uno stato pervasivo di terrore, testimoniano a sufficienza gli effetti, tragicamente reali, del fenomeno.

L’autore tratta poi gli episodi di panico collettivo in cui interi gruppi di persone sviluppano sintomi in relazione a cause organiche dubbie o provate come inesistenti – ad esempio, in relazione a uno strano odore percepito nell’aria, che viene imputato al diffondersi di sostanze tossiche, o a morsi d’insetto normalmente innocui. In questi casi, lo sviluppo dei sintomi è, per così dire, “corale”: al diffondersi dell’allarme, i segni attesi vengono manifestati da un’alta percentuale dei soggetti coinvolti.
Si può quindi escludere che l’effetto nocebo colpisca solo soggetti psico-emotivamente fragili o inclini alla crisi: esso può manifestarsi globalmente su un’intera popolazione esposta a una circostanza percepita o descritta come rischiosa. L’analisi comparata di questo genere di episodi evidenzia diversi fatti notevoli: essi tendono a verificarsi in luoghi dove le persone sono assembrate in gran numero (scuole, fabbriche, città); coinvolgono prevalentemente le classi socioeconomiche più fragili o precarie; e aumentano nei periodi di maggior stress sociale ed economico. La strutturazione sociale gioca dunque un ruolo chiave nella diffusione e nella pericolosità degli eventi.

Walter B. Cannon
Questa riflessione può essere ampliata fino a toccare una delle zone più critiche e delicate dell’esistenza umana:
«Il fenomeno nocebo è un effetto collaterale della cultura umana. Esso suggerisce che le categorie etnomediche di una certa società non solo descrivono le condizioni di malattia che si reputano esistenti, ma possono anche indurre tali condizioni inducendo l’aspettativa che esse si presenteranno. […] In questo modo, un sistema culturale che si ritiene solitamente essere al servizio della funzione di guarigione, può anche avere un effetto collaterale paradossale e indurre quelle stesse patologie che cerca di prevenire o di curare» (p. 350).
Si parla infatti, in antropologia medica e in etnopsichiatria, di funzione patoplastica e funzione patogenetica delle culture.
La prima è, per così dire, il lato in sole del processo di plasmazione bioculturale: la capacità collettiva di dare forma alle malattie, di non lasciare la crisi nel disastro dell’insensatezza.
La seconda ne è la parte in ombra: ogni messa in forma è anche, inevitabilmente, un’induzione. In fin dei conti, questo significa che non c’è modo di evitare l’effetto nocebo, che nasce dal movimento stesso che rende possibile la terapia, nella zona in penombra della strutturazione culturale e dell’immaginario dove l’ambiguità è la regola. Anche così, però, c’è modo e modo di navigare nell’ambiguità che lega malattia, terapia, diagnosi, cura, placebo e nocebo: è possibile, ad esempio, che le culture in cui l’esistenza di quest’intreccio è ammessa e osservata si trovino in una posizione migliore per contenerne gli effetti.
La prima è, per così dire, il lato in sole del processo di plasmazione bioculturale: la capacità collettiva di dare forma alle malattie, di non lasciare la crisi nel disastro dell’insensatezza.
La seconda ne è la parte in ombra: ogni messa in forma è anche, inevitabilmente, un’induzione. In fin dei conti, questo significa che non c’è modo di evitare l’effetto nocebo, che nasce dal movimento stesso che rende possibile la terapia, nella zona in penombra della strutturazione culturale e dell’immaginario dove l’ambiguità è la regola. Anche così, però, c’è modo e modo di navigare nell’ambiguità che lega malattia, terapia, diagnosi, cura, placebo e nocebo: è possibile, ad esempio, che le culture in cui l’esistenza di quest’intreccio è ammessa e osservata si trovino in una posizione migliore per contenerne gli effetti.
Come molti autori successivi, Hahn precisa e conferma le celebri ipotesi avanzate da Cannon in anni di conflitto mondiale: rabbia e paura possono causare il tracollo dell’equilibrio neurovegetativo e questo può essere talmente grave da paralizzare le funzioni vitali e indurre la morte. È il caso delle cosiddette “morti voodoo”, lungamente descritte dagli etnologi, ma anche di molte osservazioni fatte da medici sui fronti di guerra: il terrore degli eventi e lo stress prolungato della situazione di guerra possono avere esiti letali anche in assenza di lesioni organiche.
5. Fra circensi e bravi padri di famiglia
L’attuale pandemia da coronavirus non può che interrogare chiunque si occupi di antropologia medica. Più nello specifico, ci sembra ineludibile una riflessione complessa sull’andamento differenziale dell’infettività e della mortalità nelle diverse nazioni colpite e, per l’Italia, nelle diverse regioni. Fermo restando che ipotesi epidemiologiche affidabili saranno possibili solo quando (e se) si arriverà a un computo realistico, e internazionalmente confrontabile, dei numeri, il caso italiano – e in particolare quello tremendo della Lombardia – manifestano una fenomenologia specifica nella quale conviene cominciare ad addentrarsi.
Arriviamo così all’ipotesi eziologica che vorremmo aggiungere alla spiegazione degli eventi. La enunciamo fin da subito, di modo che sia possibile tenerla presente lungo il resto dell’argomentazione: è possibile che la gestione della crisi operata all’intersezione fra politiche nazionali e locali e le strategie comunicative delle istituzioni pubbliche e dei grandi mezzi d’informazione abbiano innalzato il rischio di mortalità da Covid-19 anche – e sottolineiamo: anche – inducendo paura, panico e paranoia nella popolazione.
Cominciamo con un’analisi sommaria della trattazione mediatica dell’epidemia. Sulla dinamica dei grandi mezzi di comunicazione non vale la pena insistere: nel libero mercato dell’informazione vince chi riesce a catturare l’attenzione e poi a tenerla, ed è noto che la paura è un gancio eccellente. In Italia la copertura mediatica accordata al Covid-19 è stata, fin dall’inizio, spropositata, frenetica e allarmistica.
Per cominciare, c’è stato un convergere esclusivo e ossessivo su questo singolo tema. Alcuni ricorderanno la distanza abissale, nelle prime due settimane di marzo, fra quanto si leggeva sui giornali italiani e quanto proponevano invece le testate francesi, inglesi e tedesche – discrepanza che è stata causa di angosce bidirezionali: quella degli italiani all’estero, che sospettavano una minimizzazione del problema da parte delle nazioni ospitanti; e quella degli italiani in Italia, che sospettavano un’esagerazione del problema da parte del nostro governo. In questa fase, le celebrità dell’infosfera hanno fatto per intero la loro parte, allarmismo e negazionismo esasperati hanno occupato l’intero della scena pubblica e il premio della visibilità è andato a chi ha urlato più forte usando l’insulto in luogo delle argomentazioni.
 Subito dopo, in concomitanza con il rapido susseguirsi dei DPCM, immagini di medici in tuta spaziale che parevano tratte da B-movies hollywoodiani hanno invaso gli schermi, mentre il conteggio di morti e infettati diventava un macabro rituale quotidiano. All’indomani del primo sconcerto, la comunicazione ha imboccato con molta decisione una battente retorica di stampo bellico, punteggiata di richiami all’immaginario apocalittico che giace nell’inconscio sociale già da decenni.
Subito dopo, in concomitanza con il rapido susseguirsi dei DPCM, immagini di medici in tuta spaziale che parevano tratte da B-movies hollywoodiani hanno invaso gli schermi, mentre il conteggio di morti e infettati diventava un macabro rituale quotidiano. All’indomani del primo sconcerto, la comunicazione ha imboccato con molta decisione una battente retorica di stampo bellico, punteggiata di richiami all’immaginario apocalittico che giace nell’inconscio sociale già da decenni.
Anziché informare sulla situazione – e cioè esporre quel che è noto, ammettere ciò che non è noto e discutere delle diverse scelte possibili – le retoriche di guerra hanno compattato l’inconscio sociale intorno alle necessità straordinarie imposte dalla lotta senza quartiere contro un nemico invisibile, ubiquo e pericolosissimo.
Per sua parte, la politica italiana si è espressa, sia a livello regionale che a livello nazionale, nelle consuete forme paternalistiche e opportunistiche: ad esempio, nelle decisioni sull’uso delle strutture; nella scelta di non fare (o fare) i tamponi; nei comandi contraddittori sull’uso delle mascherine. Anziché coordinare le diverse competenze del settore pubblico per gestire la crisi nella maniera più efficiente e meno traumatica possibile, le scelte delle regioni e del governo hanno riverberato in modo feroce sulle possibilità operative dei medici e del personale sanitario, imbrigliando i loro interventi in funzione della convenienza politica e delle necessità elettorali di una schiera di “uomini forti”. La compensazione simbolica si è giocata sull’eroizzazione del personale sanitario, a tutto vantaggio del melò emotivo bellico-nazionalista.
Nella stessa direzione è andato anche il varo di misure di contenimento particolarmente vessatorie rispetto a quelle di altre nazioni. Ferma restando la necessità di rallentare il contagio e la difficoltà, in situazioni di buio epistemologico, di discernere fra ciò che è efficace e ciò che non lo è, le disposizioni italiane sono arrivate all’assurdo: divieto di uscire insieme per chi vive nella stessa casa; di passeggiare da soli nei parchi o nei boschi; di stare all’aria aperta; di far uscire i bambini; di fare la spesa fuori dal quartiere di residenza; di andare in spiaggia. Assurdità di dubbia tenuta costituzionale, che hanno criminalizzato gli affetti e le reti familiari e costretto alla clandestinità le realtà territoriali solidali, che garantivano la sopravvivenza alle fasce più deboli ed emarginate. E che, di conseguenza, potevano essere fatte rispettare solo autorizzando i controllori all’abuso.
Analogamente, alcune delle misure ipotizzate e ampiamente mediatizzate – lavare le strade con ammoniaca, lasciare la spesa fuori dalla porta di casa per giorni, disinfettare i vestiti con cui si esce – possono suonare ragionevoli solo in un progetto delirante, e dalle assonanze orribili, di igienizzazione del mondo.
La stampa, a ruota, ha preferito ammonire e rinforzare che spiegare e discutere criticamente. Come nota Osservamedia Sardegna,
«a fronte di limitazioni della libertà collettiva molto pesanti imposte per le politiche di contenimento dell’epidemia, le motivazioni scientifiche alla base dei provvedimenti sono state punto o poco spiegate, privilegiando una ossessiva ripetizione delle istruzioni da rispettare, esattamente come farebbe un adulto a un bambino. Questa impostazione paternalista e totalmente digiuna delle più elementari basi democratiche, continua a venire propagandata dagli attori legittimi in campo in questo momento a parlare dell’emergenza: esperti, politici e commentatori, ed ha assunto venature isteriche di massa nella sua diffusione sociale attraverso le piattaforme digitali» (p. 7).
Fino al caso di chi, come Barbara D’Urso, ha fatto audience mostrando cacce all’uomo con i droni e istigando il pubblico a dar corso a emozioni da Ku Klux Klan.

Qui troviamo un altro boccone amaro, quello delle emozioni politiche, il modo in cui il discorso pubblico dà forma, sostanza e durata a ciò che proviamo verso gruppi di “altri”: stranieri, migranti, membri di altre classi sociali, soggetti appartenenti a gruppi etnici o razzializzati, cittadini di nazioni nemiche ecc. In relazione all’epidemia di Covid-19, l’infosfera italiana ci ha mostrato non solo come avremmo dovuto comportarci, ma anche cosa dovevamo provare, generando emozioni, odî e polarizzazioni i cui effetti misureremo in tutta la loro portata solo all’uscita dall’emergenza.
6. Una fine del mondo in tonalità minore
Speciale attenzione meritano il distanziamento sociale, che vieta per legge il contatto con il prossimo, e il divieto di celebrare riti di qualsiasi genere.
Un’ampia varietà di ricerche psicologiche, etologiche ed endocrinologiche indicano che la mancanza di contatto fisico induce nei neonati sindromi che vanno dalla depressione al nanismo, fino a sfociare, nei casi più gravi, nella morte; e che la regolazione emotiva e fisiologica del nostro essere dipende dall’insieme delle nostre relazioni. Ed è noto che l’isolamento totale è, da sempre, un metodo di tortura impiegato nelle carceri. Anche concedendo che la capacità di tenuta degli adulti sia ben più tetragona di quella dei neonati, è indispensabile chiedersi a quali effetti psichici e fisici possa andare incontro un’intera popolazione sottoposta a un regime uniforme di isolamento.
I riti pubblici – lauree, matrimoni, battesimi, funerali – sono stati vietati tout court anche laddove sarebbe stato possibile farli in tutta sicurezza a ranghi ridotti. Particolarmente tragico, come altri ha fatto notare, la combinazione fra l’isolamento totale dei malati di Covid-19 negli ospedali e il divieto di salutarli una volta morti. Non c’è alcuna sicura ragione medica a fondamento di una norma così crudele, ma solo una scelta politica dettata dalla necessità di fare troppo dopo che si era fatto troppo poco. Se ora proiettiamo la situazione italiana sullo sfondo della letteratura antropologica, siamo costretti ad ammettere che si tratta di una congiuntura talmente gravi da mettere a rischio la tenuta stessa di un mondo – come, appunto, è successo in Lombardia.
L’apocalisse culturale descritta da de Martino arriva quando, a un gruppo umano nel suo insieme, non è possibile né mantenere gli istituti precedenti, né inventarne di nuovi – gli istituti più cruciali essendo quelli che regolano i momenti critici dell’esistenza: nascita, morte, passaggi di status. Quando la consuetudine è sovrascritta per decreto, quando gli istituti del vivere umano (quelli che ci fanno umani: v. prima parte di questo articolo) sono passibili di annullamento improvviso, quel che ne risulta è la crisi della presenza individuale e collettiva.
Proprio perché sono misure gravissime, distanziamento sociale e sospensione dei riti avrebbero dovuto essere trattati in tutt’altra maniera: si trattava di rendere meno traumatiche possibile misure che hanno comunque un portato destrutturante. Perché questo fosse possibile, tuttavia, si sarebbe dovuto attribuire agli italiani lo statuto di adulti in grado di valutare i rischi e di attenersi a comportamenti ragionevoli – ipotesi che, con ogni evidenza, non è quella del governo.
7. Atmosfear. Soggetti di terrore
Il prevedibile effetto di questa totalizzazione del discorso pubblico è stata dapprima la paralisi conoscitiva, una situazione temibile che richiama quel che succede nelle circostanze costruite apposta per de-umanizzare i soggetti tramite la dissociazione di parole e cose, di linguaggio e mondo. Subito dopo sono arrivati il bisogno di sicurezza e la necessità emotiva di aderire a una qualche interpretazione comune dei fatti e di azione collettiva. Bisogni umanissimi, in tempi di incertezza, che tuttavia non hanno prodotto (se non in settori ancora minoritari) aperture critiche e sguardi innovativi, e sui quali si è invece innestata di una forma particolarmente ripugnante di unità nazionale di stampo piagnucoloso, consolatorio e applaudente che ben merita la celebre definizione che ne diede Brecht.
 Un’ampia letteratura psicosociale indaga questi fenomeni; nel caso italiano, esso si esprime, tra l’altro, con la delazione dei vicini e con l’uso diffuso delle mascherine come testimonianza pubblica di adesione a una messinscena sociale che rassicura e permette di posizionarsi dal lato giusto della barriera che separa gli onesti e adempienti cittadini dai colpevoli untori.
Un’ampia letteratura psicosociale indaga questi fenomeni; nel caso italiano, esso si esprime, tra l’altro, con la delazione dei vicini e con l’uso diffuso delle mascherine come testimonianza pubblica di adesione a una messinscena sociale che rassicura e permette di posizionarsi dal lato giusto della barriera che separa gli onesti e adempienti cittadini dai colpevoli untori.
Gli esiti di questo clima nazionale non hanno tanto a che fare con le posizioni intellettuali dei singoli individui, quanto con un sentire diffuso mediaticamente indotto. Ferma restando non solo la sensatezza, ma la necessità di proteggersi e proteggere (specie nel caso delle fasce più a rischio), la questione è un’altra: come già visto nei peggiori decenni del Novecento, la possibilità di distanza critica sparisce, la perplessità è già tradimento.
È osservazione comune come, anche all’interno degli ambienti politicamente più attenti, sia necessario astenersi da osservazioni critiche in merito agli eventi pandemici per non rischiare riprovazione, scontri o rotture. Questa polarizzazione guerresca, insieme al bisogno emotivo di aderire alla logica del confinamento, è un sintomo.
In mezzo a tutto ciò, il terrore del virus domina pensieri e movimenti. Terrore, e non paura: come scriveva de Martino, fra la paura che induce a un’azione ponderata e il terrore di chi è dominato da un pensiero fisso passa una forma di alienazione psichica. E proprio qui sta il punto: quest’alienazione non è arrivata per caso, ma è il prodotto di scelte politiche e comunicative; è l’esito di un battage propriamente terroristico.
La via prescrittiva paternalista e poliziesca – #iorestoacasa, applausi alla finestra, in emergenza non si pensa ma si agisce, non c’è scelta, rinuncia a ogni diritto, procurati il lasciapassare, accetta ogni controllo da parte delle forze dell’ordine, lasciati tracciare – è una pista magistrale per il totalitarismo del pensiero. Inoltre, produce un circolo vizioso emotivo-cognitivo particolarmente perverso: non solo chi rompe le regole è passibile di punizione, ma rischia di morire, e di far morire, per le immediate conseguenze del suo stesso gesto. Una “colonia penale” che richiederebbe la penna di un novello Kafka.
Lo ripetiamo ancora una volta: in quest’articolo non è in discussione la pericolosità del Covid-19 né la necessità di misure straordinarie di contenimento, in particolare a fronte della scarsa tenuta del sistema sanitario. Ciò che è in discussione è la pericolosità dell’induzione di terrore da parte di chi è delegato alla gestione della cosa pubblica e all’informazione.
È poi notevole, in tutto ciò, come la manipolazione informativa induca scandalo per ogni morte direttamente ascrivibile a un fallimento dell’azione terapeutica (com’è appunto il caso del Covid-19, almeno nei casi che si è scelto di riconoscere come tali tramite ricorso al tampone), mentre lascia del tutto in ombra i numeri delle morti indirette dovute a fattori socio-ambientali – ad esempio quelle derivanti dall’inquinamento che in Italia, secondo Greenpeace, sono circa 56.000 all’anno.
È il trionfo della chiusura dell’individuo in se stesso e dell’atomizzazione: quel che dà senso al mondo e al vivere non sta nella relazione con altro e altri, nella condivisione di un ambiente comune, nel con-divenire, ma si gioca esclusivamente nell’interiorità dei soggetti.
La paura dell’altro, del contatto, del contagio, che già dilagava in un ampio settore della popolazione e si esprimeva in forme razziste e talvolta simil-fasciste, trova così piena e legittima espressione non più nei confronti di un particolare gruppo umano, ma nei confronti di chiunque altro. È una specie di “razzismo totale”, che esclude tutti e tutto dalla possibilità di una relazione umanamente sensata: in certe zone d’Italia i bambini indossano mascherine chirurgiche perfettamente inutili per andare a giocare nel giardino di casa.
Qui troviamo la chiusura propriamente totalitaria di un circuito perverso e pericolosissimo: tanto maggiore la paura dell’altro e il bisogno ossessivo di proteggersi dall’esposizione, tanto più ci si qualifica come bravi e obbedienti cittadini. È il circolo vizioso e psicopatologico nel quale molti, oggi, si trovano murati (ben descritto da questo video di Zerocalcare).
8. Dal terrore al rischio differenziale di morte
La violenza strutturale dei sistemi sociali causa malattia e morte: il fatto è talmente noto che non mette conto insistervi. A questo punto, tuttavia, ci si può porre un’altra domanda: è possibile che scelte di contenimento assurde e imposte con violenza, legittimazione della paranoia e induzione di terrore inneschino stati psicofisiologici che peggiorano la sintomatologia e predispongono a una maggiore gravità del fenomeno patologico, tanto nella popolazione in generale che, soprattutto, nella fascia di popolazione già soggetta a violenza strutturale?
Le ricerche presentate sopra autorizzano almeno la formulazione della questione. Se pure, da un certo punto di vista, il virus «non guarda in faccia nessuno», né la morbilità né la mortalità da coronavirus è altrettanto equamente distribuita fra le nazioni e fra le classi sociali. Non è difficile supporre che la gravità temuta dell’infezione da Covid-19 e le speranze sul suo decorso siano peggiori in chi vive in condizioni economiche ed esistenziali già precarie; e che la difficoltà di accesso alle cure (tanto quelle ospedaliere quanto quelle diffuse territoriali) sia un pesante fattore di aggravamento.
Nel caso dell’Italia, si può ipotizzare che la durezza delle politiche di contenimento e le scelte comunicative dei media abbiano avuto un ruolo nell’induzione di uno stato psicologico di angoscia e panico, con conseguenti effetti sul sistema immunitario e sulla possibilità di reazione al virus.
Il caso della Lombardia sembra esemplificare quanto detto nella maniera più tragica possibile. Ancora una volta, il quadro non sopporta semplificazioni: in un territorio relativamente piccolo e in un tempo relativamente breve si sono concentrati eventi e fattori di rischio in numero esorbitante, che “spiegano” qualcosa solo nel loro insieme.
Il primo fattore è la densità abitativa più alta d’Italia insieme a quella dalla Campania, con il Lazio terzo a larga distanza. Poi c’è la più alta densità di imprese e industrie sul territorio nazionale, a cui si accompagna l’usuale propensione del padronato al regolamento di conti col lavoro salariato. Un elemento cruciale è dato dall’elevatissimo inquinamento della pianura padana e dai suoi effetti avversi sull’apparato respiratorio e sulla salute generale. A ciò va sommato il modello sanitario della Regione Lombardia, basato sulla privatizzazione dei servizi e sulla messa a profitto della salute: fino a ieri cantato come esempio virtuoso da esportare, alla prova dei fatti si è rivelato non solo inadeguato, ma gravemente inadempiente.
A coronamento, un governo regionale passato in pochi giorni dalla negazione del problema (la partita calcistica Atalanta-Valencia, il ritardo nel chiudere il settore produttivo) al panico (l’utilizzo delle RSA come dispositivi di confino degli infettati, il maldestro tentativo di autoassolversi per decreto, e via dicendo).
Ora, quale reazione ci si può aspettare, se non il panico, da una popolazione esposta a scelte azzardate, al collasso del proprio sistema sanitario, martellata senza tregua dalla retorica apocalittica dai media, nel momento stesso in cui si vietano gesti tanto fondamentali per la tenuta psichica e collettiva come le relazioni familiari, le chiacchiere per strada e il saluto ai morti?
Si potrebbe allora ipotizzare che concause – sia pur minime – della mortalità lombarda siano state l’inquietudine e la paura di chi si è trovato a vivere una crisi terribile come la pandemia da coronavirus dovendosela cavare sostanzialmente da solo, sotto un intreccio di violenza strutturale, collasso del sistema sanitario, norme approssimative e/o vessatorie, paternalismo e terrore mediatico; uno stato di apprensione peggiorato dal progredire stesso della vicenda lombarda – ovvero dai primi catastrofici esiti delle politiche regionali.
Per tradurre questo sospetto in qualcosa di minimamente scientifico sarebbe necessario uno studio comparato sulla morbilità/mortalità del virus in diverse nazioni in relazione alle politiche di contenimento e allo stile comunicativo dei grandi mezzi di informazione – studio che sarà possibile solo fra diversi mesi e solo ammesso che si arrivi a una qualche forma di consenso sul computo dei morti. Nondimeno, se quest’ipotesi fosse anche solo parzialmente confermata, allora le escalation retoriche a cui abbiamo assistito, lo sfruttamento della paura a scopi spettacolari e le strategie comunicative degli “uomini forti” dovrebbero essere considerati con tutta la severità che si applica ai gesti carichi di conseguenze.
La società dello spettacolo è una forma di cattura integrale dei soggetti, che li costringe a vivere e morire secondo linee finora sottratte alla pubblica riflessione. La manipolazione emotiva in vista dello share o del voto non sono trucchi innocenti, ma veri e propri attacchi all’integrità dei soggetti esposti. I loro effetti andrebbero dunque aggiunti sul piatto delle molte responsabilità politiche già evidenti, accanto a quelle per la distruzione della sanità pubblica e dell’ambiente della pianura padana.
9. Costruire la possibilità della fiducia
All’inizio del lockdown, Giorgio Agamben ha scritto che la gestione di questa crisi ha aspetti che richiamano in modo inquietante gli spettri del totalitarismo. Il linciaggio morale che ne è seguito è stato un vero e proprio avvertimento pedagogico per chi nutre gli stessi timori: meglio tenerli per sé… Non è il caso quindi, in questa sede, di sprecare le parole o di usarle in modo leggero. Al momento è impossibile stabilire se le restrizioni a cui siamo sottoposti siano solo quelle momentaneamente utili al contenimento del virus – come tutti, ovviamente, speriamo – o se siano l’incipit di un precipitare delle nostre vite in forme estreme di isolamento e controllo. Lo scopriremo nei prossimi mesi. I timbri della comunicazione, l’asprezza delle norme, la difficoltà di articolare pubblicamente un discorso critico e il moltiplicarsi degli spettri nell’inconscio sociale non sono di buon auspicio.
Già da ora, tuttavia, si può prevedere che, se la piega fosse davvero di tipo totalitario, saremo in grado di opporci solo uscendo dalla paralisi del terrore indotto, rifiutando di barattare l’intero dell’esistenza – che, per sua natura, è avventuroso e comporta rischi – per un deserto perfettamente igienizzato e sperimentando nuove forme di socialità e di azione. Si rischia, una volta di più, la barbarie di una lotta giocata intorno al maggiore o minore timore della morte – ma potrebbe esserci un’altra possibilità.
Hahn terminava il suo articolo del 1999 con queste parole:
«Il fenomeno placebo-nocebo suggerisce che potrebbe essere più sano peccare di ottimismo» (p. 351).
È la direzione che suggeriscono tutte le migliori intelligenze critiche dei nostri anni: contrariamente a quanto prevede l’ontologia cartesiana, l’ingrediente cruciale nei processi più delicati – crescita, guarigione, creazione di gruppi, deliberazioni collettive ecc. – è la fiducia, la possibilità di affidarsi. E poiché la fiducia non è un dato di natura, essa va costruita, resa possibile. Non è semplice, dopo quarant’anni di neoliberismo – e quindi di scelte al ribasso, di darwinismo sociale, di ottundimento dell’immaginazione, di emergenze, di alternative infernali – ma la possibilità migliore che abbiamo è quella di riattivare intelligenza, sensibilità, coraggio e passioni gioiose.
Per farlo, bisogna uscire dalla cattura operata su di noi dalla “stregoneria capitalista” e ricominciare a immaginare altre prospettive di breve, medio e lungo termine. Si potrebbe cominciare in modo citoyenne, prevedendo che chi ha un potere differenziale sia consapevole e responsabile delle sue scelte così come di ciò che comunica e meta-comunica; che l’azione terapeutica sia liberata tanto dalle procedure protocollari come dall’esigenza di difendersi sul piano legale, e possa così tornare a occuparsi anche degli aspetti politici della salute; che alla dimensione relazionale dei soggetti sia restituita tutta la sua rilevanza.
Chi prospera sul terrore altrui, i cantori di passioni tristi e tutti gli ometti forti andrebbero accolti con le risate che meritano. Ma è chiaro che la possibilità stessa di muovere in questa direzione, di abitare un immaginario meno avvelenato, richiede anche un ripensamento globale degli assetti sociali, della nostra relazione con gli altri viventi e non viventi, di cosa vuol dire vivere bene. La scommessa sulla tenuta del nostro essere, su una certa felicità nonostante il rischio, sulla possibilità di una buona vita a cui si accompagni una buona morte è la via d’uscita dalla prigione mentale e fisica nella quale il terrore del virus rischia di confinarci.
Approfondimenti.
Una proposta di tre letture per ciascuno degli argomenti toccati nel post.
Sulla “grande partizione” che separa natura e cultura: [1] D. Haraway (1988), Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial perspective, «Feminist Studies» 14, 3, pp. 575-599; [2] B. Latour (1991), Non siamo mai stati moderni. Saggio di antropologia simmetrica, Eleuthera, Milano 2009; [3] I. Stengers (1994), La Grande partizione, «I Fogli di ORISS», n. 29-30 (2008), pp. 47-6.
Sul “buio epistemologico” e sugli strumenti per navigarlo: [1] M. Taussig (1987), Shamanism, Colonialism and the Wild Man: a Study in Terror and Healing, University of Chicago Press, Chicago; [2] E. Melandri (1968), La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia, Quodlibet, Macerata 2004; [3] C. Ginzburg (1979), “Spie. Radici di un paradigma indiziario”, in A. Gargani (a cura di), Crisi della ragione, Einaudi, Torino 1979, pp. 57-106.
Sulla “costruzione degli umani”: [1] V. Despret (2001), Le emozioni. Etnopsicologia dell’autenticità, Elèuthera, Milano 2002; [2] T. Ingold & G. Palsson (2013), Biosocial becomings. Integrating social and biological anthropology, Cambridge University Press, Cambridge; [3] F. Remotti (2011), Cultura. Dalla complessità all’impoverimento, Laterza, Roma-Bari.
Sull’antropologia medica e l’etnopsichiatria: [1] H.A. Baer, M. Singer & I. Susser (1997), Medical anthropology and the world system. A critical perspective. Bergin & Garvey, Westport (U.S.A.) and London; [2] P. Coppo (2003), Tra psiche e culture. Elementi di etnopsichiatria. Bollati Boringhieri, Torino 2003; [3] I. Quaranta I. ed. (2006), Antropologia medica. I testi fondamentali, Raffaello Cortina, Milano.
Su credenza, placebo e nocebo: [1] W.B. Cannon (1942), “Voodoo” death, «American Anthropologist», New Series, 44 (2), pp. 169-181; [2] R. Hahn & A. Kleinmann (1983), Belief as pathogen, belief as medicine: “Voodoo death” and the “placebo phenomenon” in anthropological perspective, «Medical Anthropology Quarterly», 14 (4), 3+16-19; [3] R. Hahn (1999), “Expectations of sickness: concept and evidence of the nocebo phenomenon”, in I. Kirsch, How expectancies shape experience, American Psychological Association, Washington D.C. 1999, pp. 333-356.
Sulla violenza strutturale e le emozioni politiche: [1] M. Marmot (2004), The Status Syndrome. How Social Standing Affects Our Health and Longevity, Owl Books, New York; [2] F. Sironi (2007), Violenze collettive. Saggio di psicologia geopolitica clinica, Feltrinelli, Milano 2010; [3] R. Beneduce (2010), Archeologie del trauma. Un’antropologia del sottosuolo. Laterza, Roma-Bari 2010.
Sulla presa del capitalismo e la possibilità di costruire fiducia: [1] A. Tsing, H. Swanson, E. Gan & N. Bubandt (2017), Arts of living on a damaged planet. Ghosts of the anthropocene, The University of Minnesota Press, Minneapolis. [2] D. Greaber (2011), Revolutions in Reverse: Essays on Politics, Violence, Art, and Imagination, Minor Compositions / Autonomedia, New York 2011; [3] P. Bartolini & S. Consigliere (2019), Strumenti di cattura. Per una critica dell’immaginario tecno-capitalista, Jaca Book, Milano.
–
* Stefania Consigliere è ricercatrice all’università di Genova, dove insegna Antropologia e Antropologia dei sistemi di conoscenza, e dove coordina il Laboratorio Mondi Multipli, luogo di ricerca e di sperimentazione delle conseguenze ontologiche, epistemologiche, etiche, politiche ed esistenziali che derivano dal precetto antropologico di “prendere gli altri sul serio”. Altre informazioni e articoli su: www.stefaniaconsigliere.it.
Cristina Zavaroni, antropologa culturale ed etnologa africanista, ha una lunga esperienza di ricerca presso i Bakonzo del Rwenzori in Uganda. Specializzata in antropologia cognitiva ed etnopsichiatria, lavora da diversi anni come consulente per l’Associazione Mamre Onlus di Torino. Dal 2013 fa parte del Laboratorio Mondi Multipli.
5 Maggio 2020



Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.